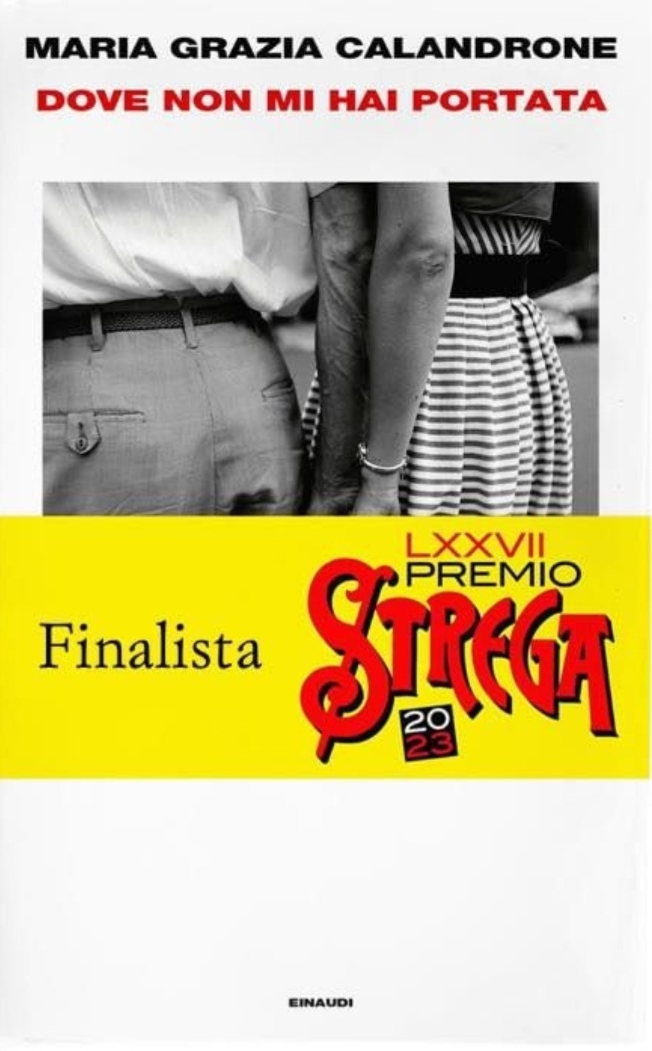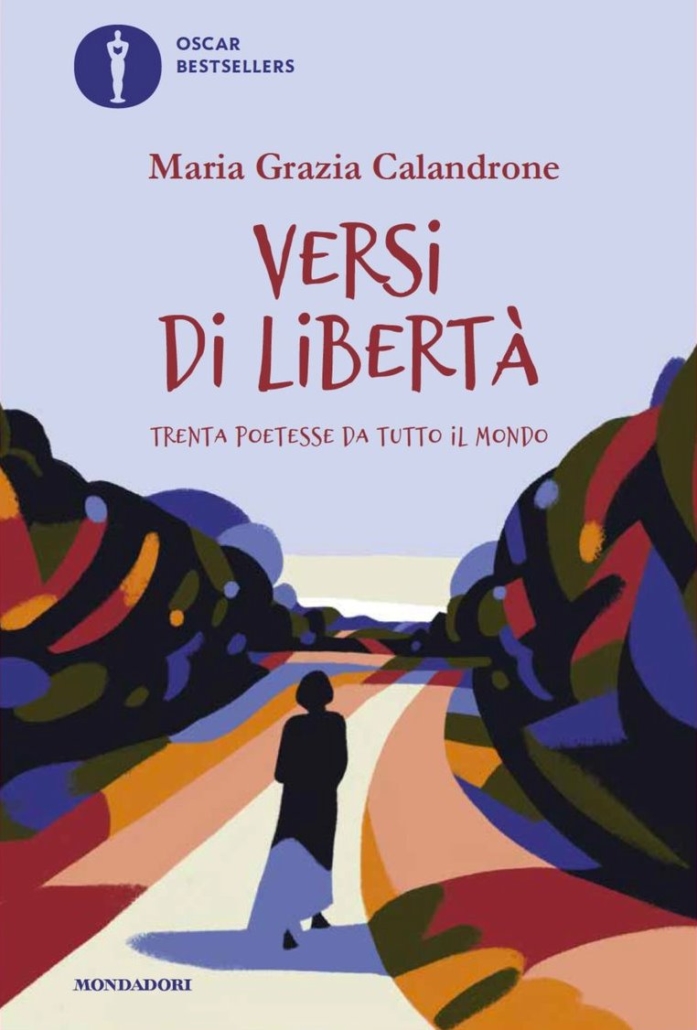ULTIMI LIBRI
TELEVISIONE, CINEMA, VIDEO
RADIO
PROSSIMI EVENTI
| Data / Ora | Evento |
|---|---|
|
20 Aprile 2024 17:00 |
Scuola Confalonieri, Roma |
|
22 Aprile 2024 20:45 |
Crema |
|
24 Aprile 2024 15:30 - 17:00 |
Giornata di Studi Italiani, Università di Friburgo (online) |
|
29 Aprile 2024 11:00 - 13:00 |
Conversazioni a Pescara, Auditorium Flaiano |
|
30 Aprile 2024 10:00 - 11:00 |
Società Dante Alighieri per lo Strega, Benevento (online) |
|
4 Maggio 2024 12:00 - 13:30 |
Torre Annunziata |
|
10 Maggio 2024 21:00 |
Palazzo San Carlo, Albenga |
|
11 Maggio 2024 10:30 - 12:30 |
Palazzo San Carlo, Albenga |
|
13 Maggio 2024 - 14 Maggio 2024 16:00 |
Holden, Torino |
|
16 Maggio 2024 15:00 - 17:00 |
Ciclo formativo per docenti sulla didattica della poesia - online |