Homo Sapiens n. 4 (Teseo, 2.2000)
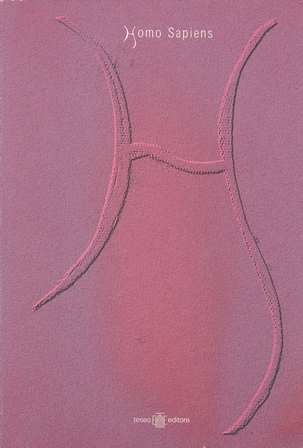
- Homo Sapiens
- rivista di filosofia, arte e letteratura
- anno III n. 4 – febbraio 2000
- Teseo Editore
Teresa di Lisieux, al secolo Thérèse Martin, è nata ad Alençon il 2.1. 1873 ed è morta nel Carmelo di Lisieux all’età di ventiquattro anni. Nel centenario della morte è stata dichiarata Dottore della Chiesa. Resta di lei, oltre al discusso esempio di un sacrificio consumato nella tenace volontà di essere artefice anziché vittima del proprio assottigliamento, l’autobiografia spirituale Storia di un’anima e qualche immagine, che ha agglomerato e velato di mito il suo edificio postumo, eretto dai suoi fattori su diffuse fondamenta romantiche di bellezza e tristezza.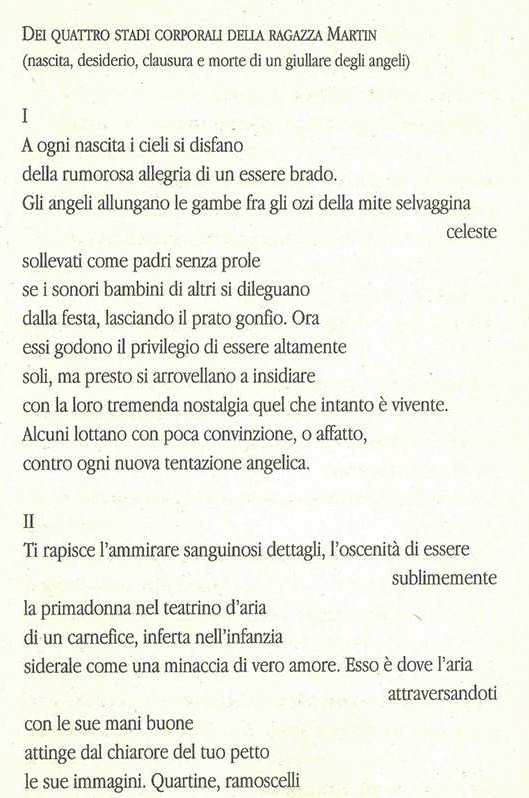
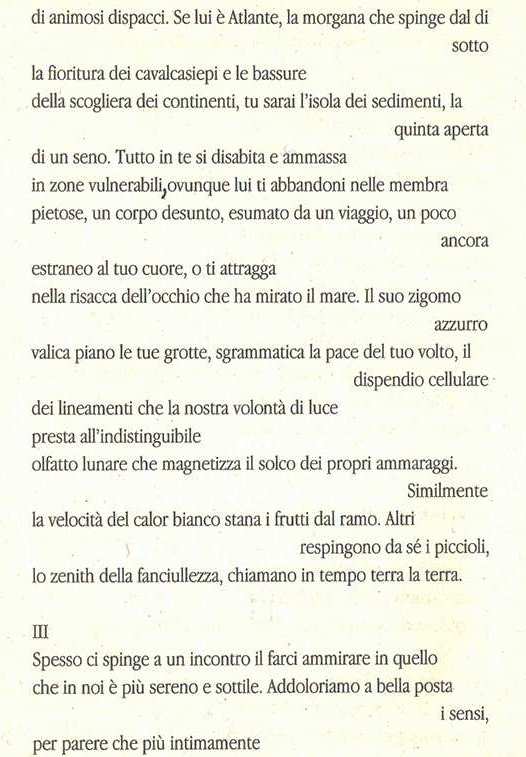
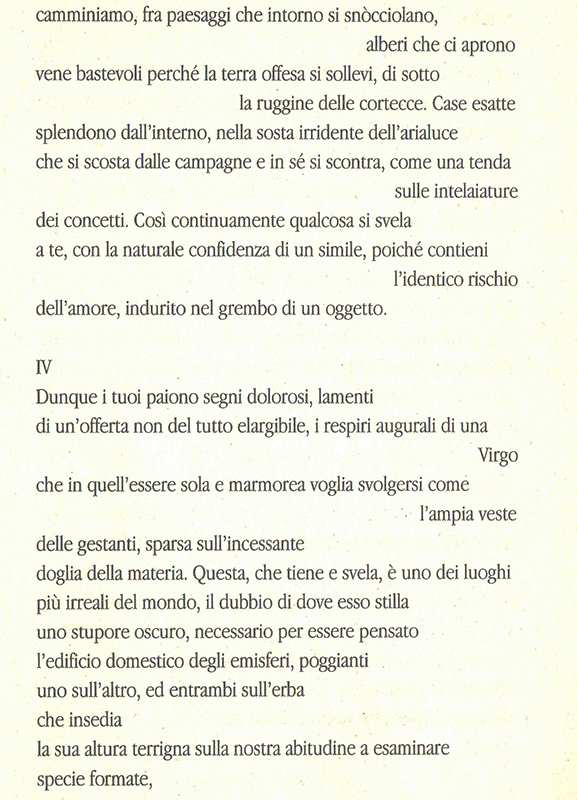
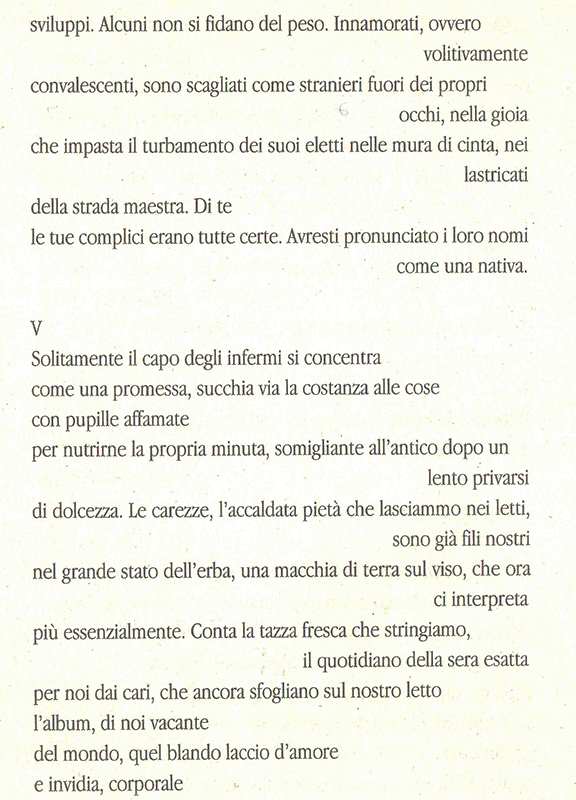
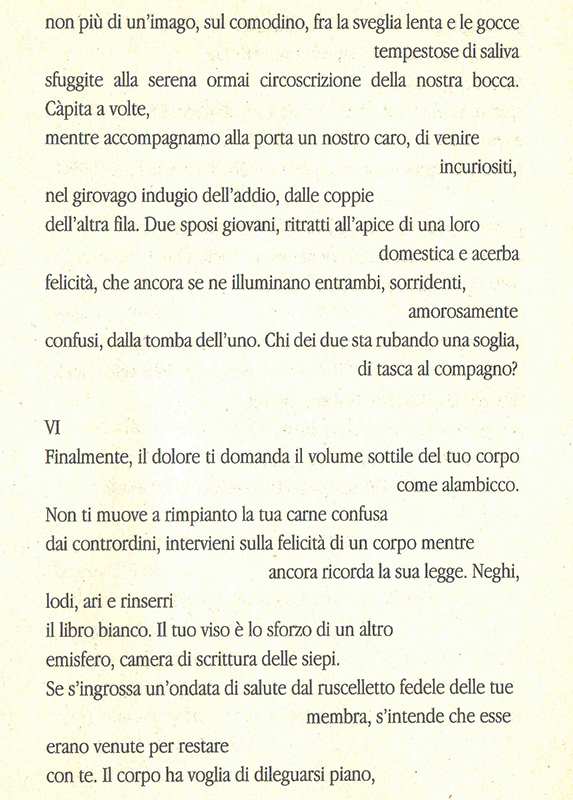
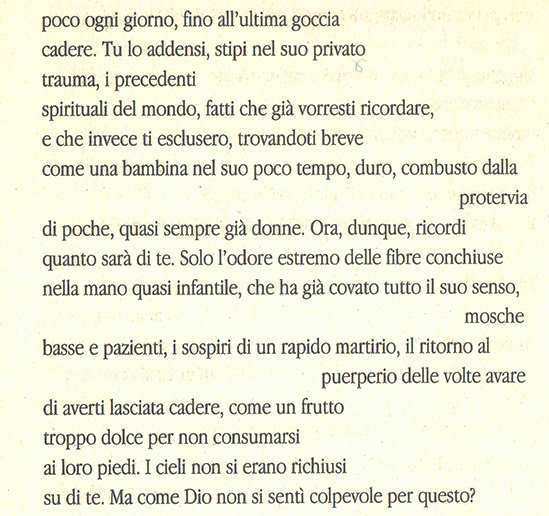
ESECUZIONE DEL NOSTRO CALMO, EFFIMERO SMARRIMENTO
(riserva presidenziale di Ostia, ferragosto 1998)
I
La fama del morire di lei
fu ascendere. Così ella commise
il sacro, ovvero tutta se stessa
è la parte che di noi occorre
semplificare, per rimanere umani.
II
Nella pura inclinazione del sole il sabato gravita, sogna
vinte spiagge
semivuote ai delta su cui biancosabbiante s’incanala l’esilità di una predestinazione. Vaga
lo sparso frùscio della nostra cadenza
di scansamento del dolore
fra i rovi e il vetroso fronte della riviera, dove uno sminuzzante rimasuglio di fiato
balneare, preme l’incline ortica al ritratto
lineamento del mare
esalato fra la testimonianza vegetale nella quale sprofonda
la piaga e la risata dell’umano
exemplum di beatitudine ai piedi del giorno, pur che la luce
naturalmente decanti
sui volumi sporgenti dal suo migrare
nella gravità delle creature
vere e lontane.
III
Poi che il pensiero che a fuggirci più tarda è la vita, ci isoliamo nel fresco
che la delimita in superficie. Ognuno
sfocia nel riconoscimento del suo chiaro
corpo, dalla massa dell’estremo pendio verderobusto
che bruscamente intona, come il miraggio degli amanti
un’ascesa maestra
fra i pini. Vige, nell’affossante corridoio di dune, il divenire lettera dei contemplanti
al bordo nero della terra, eretto
umore alfabetico
del cadere che genera il tempo
dopo il lampo, il lamento di un’anima
osservata, e per questo monotona materia
solvente, scivolìo di coscienza sulla sabbia.
IV
Nella estatica sospensione estiva
della grazia, la luce
soppesa le sue creature, la curvatura di corpi
dei quali ignora chiaroveggenza e memoria. Il più tenue
si stacca dalla sabbia
contro la quale il solido affetto del suo capo soltanto
si staglia, avanza nell’elisa
disenergia di un atto
spensierato come l’annuire dei cani
continuo nelle corse salivanti, frescosaline, dirotte
a un tardo sovrasenso di frantumazione
di acqua sottoscritta. Sostare, nel rapporto fra il destino
del proprio corpo e il silenzio emotivo
del mare, è la prima obiezione alla nostra incognita, amorosa bellezza.
V
O se in questo sacrario di ferriere
l’orazione degli alberi è copioso e cosciente uno sforare
del libero avvenire silvestre nell’alto suo
sollevamento e candore, il sesto senso della natura è la debolezza
delle nostre membra, poca cosa creata perché essa vi pensi
altre ascese
invisibili, pesi
il nostro calmo tremore.
ORATORIO DEI FALCHI SUL DESTINARSI DELL’ERRANTE
a N.
I
Andando verso questo vago pianto
o battitura d’alberi
di rugginosa roccia
dove la forma nuda del tuo essere tocca
la posa angelica, il sospiro
dei ligustri senza scoria
di passi, o della quercia
selvatica e orante, di tutta l’aria,
l’ombra e la polvere, su questa asciutta
valva, mi fa roccia
e uliveto sacro, terra
in mezzo alle aperte nuvole
che guada, l’orma esigua che in te
doleva sopra questo giallo mare
di crepacci e di muschi.
II
Il tempo ora è due volte
in te, su questo ferro
di contemplazione sacro
per l’amore che porta
la pianta eremitante dell’anima
sulle tracce della propria scomparsa
nell’intenerimento della carne
che ascendendo dà torto a se stessa, a questa bianca
profondità piena di falchi, a questa ressa intorno
odorosa e sonora
di fogliame di bacca,
la bellezza della cui ombra
e finanche il morire
delle prede, ci include.
IL MONDO E LA SUA VISIONE
I
Mai zefiro che basti a disperdere
le allusioni, l’intenzione melodica
dei suffissi, o gemme dei rami, steccati
per la navigazione
sgovernata di uccelli
e degli anni riaperti
dall’oleandro di desideri semplicemente sbocciati
dal quartiere
di radici che suggono ovatte
imbevute di stretti di mare, anima calda
di pane, ombre radiali
di bambini su la renella.
II
Dolce lagna di cardini e di larve
mentre il sonno si forma
nella testa, piegandola
a una sua ricerca di nitidezza. Dietro i ferrigni paralleli
di balaustre, l’ipotetico dire delle nostre determinate figure
verso il mare e la sua ubiqua sevizia retta dal vento.
ANATOMIA DELLO STALLO
I
Come agghiacciata in atto di allargare una fonte, abbandoni la leva
delle dita, a puntello della commessura
tra il riflusso periodico dello scontento
e la terra. Eri
ponte di carne fra la sponda dell’anima e la sua artica
resa, e per questo tuo merito spontaneo, pure mentre colpivi
nel segno sinistro della sostanza che lega
uomo a uomo, ti vedevo innocente. La vita è più reale di questa calma
apparente, e questo scalmo
per le tue prossime navigazioni, è il mio ultimo
dono. Seduta, consumo l’apprendistato
dell’assottigliamento
e del ripudio. Dalla rinuncia si riconosceranno i colpevoli.
II
Nell’aria satura di prigionia e bagliore
di conchiglie, la lamina geologica di un freddo
intromesso ai pori
di schiuma, alzata
da un camminare parallelo alle persiane
accostate, a vetro chiuso nella felicità del sonno, oltre
le picchiate di uccelli accoccolati come scarabocchi
nel vento magro del cancello
d’orto. Niente somiglia al grido degli umani, né pure
questo afrore erbaceo di vento che sconfina e sembra
altra acqua sull’acqua, tanto
schiaffeggia. Capisco cosa mi volle
suggerire la posatura degli aquiloni nel biancore di agosto, sferrati
come tamburi dell’etere, come buone novelle, prima
del temporale corso a forzare il suo perpendicolo sulla conversione del mare,
questo incipiente spavento di camminare
nell’uliveto sacro dei controcanti, occupati
da un’arte nobile e distante
come i reticoli del gelo sulla radice.
III
Secèrniti dunque, facile a non intendersi così depositato
in gocce
nell’ultimo augurio umano, la casa
che di nuovo abbandoni
senza abbandonare, ferma in un’alta
dimensione, prima
della limatura
terrestre del fiume. Ora nessuno chiama
te altrove da questo
Tevere fenditura di morti, rètore furioso, ticchettìo
dell’acido oratorio familiare, perfettamente
sovrapponibile alla verità con il trasporto della sola musica volutamente
sgradevole. Allo scadere di ogni anno,
l’astrazione del mondo invertito nel sangue degli animali.
IV
La casa resta. Essa è di chi apre le imposte e vi lascia entrare
giorno. E’ l’occhio, la nostra partecipazione
inutile e necessaria, e può essere chiusa
dalla luce. L’economia strategica del tempo
animale, demanda agli uomini la guerra
come l’iniziativa personale di corpi avvezzi al calore fino all’angustia
di dicembre, ben che non un occaso intervenga, ma un succedersi
di minuziosi ritiri, come di te che meno rimanevi
salvo in me dai pericoli del mondo
che spacca
i raffinati strumenti, l’allitterazione
di serrande semichiuse come il pianto desertico
dell’accompagnatrice. Sulle poste del sentimento
un fratto sentore di vigneti, discesi
nel margine secco fra la voce e il suo senso, nella certezza
che tutte queste cose spireranno. Il destino è stato
somma di coincidenze dedicate
all’apertura e alla ovvia evanescenza all’aria della reliquia
dei miracoli. Essi dipendono dalla moltitudine, sono il nostro giovarci
con gratitudine, di un merito altrui.
V
Ha orecchie solo per la certezza l’aperta e stanca
matematica di questa donna
intatta come chi è solo. Eradicata e invivibile, accede
allo strabico traliccio del disperso, ausculta
dalla sua fronte lontana
l’onda del tramestìo
del magma, con la inermità degli ignari che troppo
hanno veduto, con l’asprore dell’ospitalità
nel nido di un angelo. In un gesto, i venti dei suoi anni cavalcati
d’un balzo, l’ordine dei controllori di volo – notiziari di guerra
accumulati più alla svèlta
di una bambina vera – di questo tempo
breve che s’incista nella sua isola, nello sparuto flettersi di rondini
tra ferite d’aria, spuntati spifferi di finestrella bassa
e di canne. Benedetto tu sia
per la tua cecità, soffiante gemello che non soffri l’altare crudele
del vero sole. L’anima mia non ha che governo
sul suo povero grano di sale, di calma
vedovile, incrudita da un’opinione unanime di congiura.
22 maggio 1999
LO SNOCCIOLÌO INNOCENTE DE L’OLIVASTRO
Falde condominiali sul miserere dei lastricati.
Tra i muri forti di una abitazione collettiva
lente opere ginniche, scialli, improvvisi boscosi ai balconi.
Dalle città proibite di corpi estranei
ci richiamano alterchi senza lamento.
Un corpo di passaggio sostiene la sua anima borghese fra i pini. La bocca
è poca, sporcata da la materia convertita
in necessità. Si cammina tra oggetti che ci precedono
come terre infantili turbate dalla metamorfosi. Tale difformità naturale
copre gli anni come una premonizione
che la curiosità disperde.
Salire a traverso il tempo ci assomma al primo pomeriggio che muove le mandrie
delle nubi, le anfore di questo culminare
nell’agosto che trasforma le strade
di città in archeologia. Per tutta la vita teniamo vicine le poche cose reali che ci confermano
il ribollire che intuiamo sotto, di fornace in rovina.
A un davanzale
immobilizzato dalla calura, sul bordo della civiltà
interna – la meta
però, è in superficie – la bottiglia del latte. Dentro devono muoversi
bambini, metamorfosi di un dormiveglia umano.
11 ottobre 1999



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!