Bordoni Isabella (5.13)
ISABELLA BORDONI, Fortuna
a cura di maria Grazia Calandrone
Poesia n. 282, maggio 2013
Il piglio orale della scrittura di Isabella Bordoni è chiaro fin da subito e a noi interessa perché esemplifica egregiamente il dialogo tra scrittura e voce, essendo Bordoni stessa l’“attrice” in vocis et in corpore dei propri testi. Questa scrittura è dunque il sedimento fermo di un oggetto poetico tridimensionale fatto anche di voce e di corpo.
Abbiamo insistito in varie sedi intorno alla convenienza – a nostro parere – della lettura “bianca” dei testi poetici, così da rendere anche il corpo e la voce del dicitore pagine immobili e soprattutto libere dalla illegittima influenza sentimentale del dicitore stesso (che riteniamo illegittima pure nel caso in cui il dicitore sia l’autore dell’opera): l’opera, anche quando viene letta, deve farsi il più possibile contenitore degli altri, dovrebbe risultare il più vasta e il più differenziata possibile. Dunque dev’essere il più possibile anonima.
Un’autrice come Bordoni sottoscrive con il proprio lavoro questo tentativo prospettico di cicatrizzazione dello scisma (tra le arti, tra uomo e arti, ma soprattutto tra uomo e uomo), perché la sua poesia tende la mano e assume su di sé nuove parti di mondo, oltre al corpo e alla voce della sua artefice. La sua mise-en-espace dei testi, fatta anche di video e musica elettronica, esplora linguaggi liminari alla poesia, mescolando inoltre le proprie parole a quelle – per esempio – di contadini o filosofi, che esprimono ciascuno le proprie competenze culturali. Il percorso di contaminazione delle abilità contribuisce a rispondere al povero ma composito enigma dell’esistere. Bordoni sembra aspirare a una wagneriana opera totale (l’autrice ha tra l’altro dedicato un lavoro alla figura di Michel Butor, autore che esplora i flussi di coscienza attraverso una serie di opere aperte – e che dunque le immaginiamo affine nelle intenzioni). In chi tenta attraverso la poesia la difficile arte di abitare il mondo nel suo complesso e nella sua complessità anche politica, l’opera avviene come la progressiva perdita un’aspirata, da un iniziale narcissico “io chi sono” a una conclusiva, aperta e anche sbrigativa attestazione di libertà quale “io ci sono” – sperando che lo spazio lasciato vuoto dall’aspirazione venga interamente digerito dall’ispirazione.
Ma adesso, qui, delle tre dimensioni di Bordoni, abbiamo sotto gli occhi “solo” la linea concitata e interrotta di parole che ricominciano a ogni rigo e che raccontano dell’iniziazione al mondo di una bambina in età scolare, ovvero del passaggio – che tutti abbiamo compiuto – dallo stato ferino e immaginativo infantile a quello della presa in considerazione sempre più esatta del peso e dei volumi degli alberi esterni al giardino di casa e infine del mondo tutto. La bambina in questione già proviene da un branco inaddomesticabile di fratelli e sorelle (i vivi, che con-vivono – lei soprattutto, l’inattesa – con il fantasma del nato-morto che l’ha preceduta) e proviene da una prematura lontananza, da un pregresso commiato permanente fatto di carenza, da un connaturato confine terramarino che spiega il desiderio futuro della sua parola di lambire le zone che non le sono proprie. La funzione di apertura del discorso poetico credo valga, per Isabella Bordoni, a conservare per tutta la vita la cellula totipotente dell’immaginazione, l’associativa sfrenatezza infantile, o addirittura a permetterle di regredire fino al mondo equoreo, uterino, nel quale le specializzazioni non si sono ancora differenziate. Ma serve invece, nel suo slancio adulto, per una fantasiosa proiezione al futuro, per abitare il mondo e muoversi nel labirinto mondano tenendo stretto in pugno un filo rosso fatto di parole: le proprie, mescolate a quelle degli altri e delle altre arti, degli altri metodi di presa di possesso del reale. In Fortuna anche la sintassi mette in scena i cortocircuiti associativi dell’infanzia, il fiato breve del singolo segmento di pensiero e invece il magma inarginabile, perché ancora tutto sommerso, inesprimibile – e dunque tanto più potente – della linea emotiva, della infantile (infinita e sfinita, mai finita) gigantografia del reale.
I bambini non negano la solitudine, non negano il dolore: li portano come un destino, con una curva animale nella schiena, come gli asini portano il fardello e la soma, non conoscendo altra vita che quella del santo emblema di Robert Bresson, l’asino di nome Balthazar che morirà sanguinando in silenzio, attorniato da un gregge blandamente curioso di quel suo “corpo estraneo” che si spegne. Ebbene, l’infanzia, anche in poesia, è questo segnale di oltranza, la libertà che questo “corpo estraneo” si prende, di sanguinare e morire, per l’ennesima volta, sotto gli occhi di tutti.


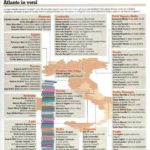

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!