poetiche (L’Ulisse n. 18 – 22.4.15)
in “L’Ulisse” n. 18 – Poetiche per il XXI secolo
SUGGESTIONANDO LA MATERIA
Un insegnante, un medico, un poliziotto, normalmente non vengono chiamati a spiegare cosa ci fanno al mondo. Il PoetaX è consapevole di essere un arto perfettamente irrisorio del corpo sociale (in questo Occidente, intendo, ché basta spostarsi di poco per venire guardati con altri occhi).
Quando arriva a essere pubblicamente interpellato sul tema, normalmente il PoetaX ha già alle spalle l’esercizio d’essersi scagionato privatamente per la propria tenebrosa passione. Ogni volta che il PoetaX è andato nelle scuole, ha dovuto spiegare l’ovvio. L’inspiegabile. Dunque, ha provato a risolverla coi fatti: dimostrando. Ha provato a leggere e basta (se si tratta di un PoetaX particolarmente generoso, si sarà spinto a leggere poesie d’altri), sperando che qualcosa del mondo che abita passasse la porta tra i regni. Se nessuna tra quelle parole si è sollevata dalla sua voce e ha toccato chi aveva davanti, la responsabilità è stata esclusivamente del PoetaX.
Naturalmente il PoetaX non ritiene affatto indispensabile che gli studenti apprezzino la poesia, tanto meno che la scrivano. Egli ne ha già abbastanza di se stesso, sebbene non si lamenti del proprio destino. Ma – va detto – quasi nessuno vive di poesia. Ne consegue che ai PoetiX venga richiesto di rappresentare la viva sintesi tra essere e fare. Non è affatto impossibile, è anzi auspicabile. Vita speculativa e vita attiva non sono affatto in contraddizione. Anzi, l’una si avvale delle vistose contraddizioni dell’altra.
Diciamo ancora che il PoetaX considera la poesia, ormai con un discreto grado di serenità, come effetto di una malattia che lo abbia indotto, da quando ha memoria (e continui impunemente a indurlo), alla introversione speculativa. E ha già ipotizzato che la macrocreatura scrivente, nel corso dei millenni, abbia tentato di nobilitare questa sua malattia sacralizzandola.
Proseguiamo però con il dire che, abitando le parole, il PoetaX ha rilevato un discreto numero di strani fenomeni che incidono, in maniera pur marginale, sul mondo delle cose e dunque in lui è nato l’inconfessabile auspicio che il sé scrivente abbia trovato nelle parole una delle possibili porte d’accesso al mondo che amerebbe definire “originario”, ma che ha abbastanza pudore per limitarsi a definire “preverbale”.
Nei giorni di umore lieve, gli pare d’improvviso significativo che la natura abbia previsto un manipolo di persone che si siano prese la briga di custodire le parole, questa pasoliniana “merce invendibile”. Gli pare addirittura significativo che la nostra cultura, come tante altre, sia fondata su un libro dove è scritto che le parole rendono “conoscibile” il mondo. Il suo buonumore non arriva però mai a evitargli di pensare che ogni scrivente scriva pro domo sua, pure ove si tratti di un serissimo apostolo.
In tema biblico, il PoetaX ricorda spesso quanto scriveva Italo Calvino: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n’è uno, è quello che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.” Posto che quella che (brutalmente e con una certa superficiale convenzionalità) denominiamo “realtà” sia davvero infernale (lo temiamo), il PoetaX si è rimboccato le maniche e si è impegnato a costruire bellezza per fare il mondo un poco più abitabile. Perché il mondo che si vede non basta a nessuno.
Se poi il poeta in questione è anche intelligente (dote che non gli è indispensabile a poetare, ma gli è stata sempre consigliata per praticare lo svolgimento di attività collaterali), egli vivrà in uno stato di sarcastico sentimentalismo, nel quale alternerà slanci d’innocenza (verrà ripetutamente detto ingenuo) al più efferato positivismo (verrà ripetutamente detto dissezionatore di sentimenti).
Ma tiriamo in ballo la sottoscritta PoetessaX, la quale ha già avuto modo di definire l’esperienza poetica (cfr. Nuovi poeti italiani 6, Einaudi 2012) “una solitudine corale”, perché il poeta, sebbene quando scrive sia perfettamente solo, vive l’esperienza di diventare un essere collettivo, di essere in comunione con la parte condivisa dell’umanità. Ovvero gli pare di raggiungere il punto profondo, che abita ogni creatura viva e morta – e a volte anche l’inanimato, il neutro, così ben descritto da Clarice Lispector in La passione secondo G.H.. Amabile, ossessiva GH, donna-cosa presa dalla passione per l’ottusa neutralità di Dio.
Con il suo libro, Lispector mette in scena la progressiva scoperta che si compie attraverso il processo creativo e l’agnizione del sovrumano laico, in quello che a prima vista pare infimo e addirittura ripugnante: la capacità di morire di una blatta, la propria reificata indifferenza per il proprio stesso morire. In quella neutra inerzia naturale, la GH di Lispector trova il gene divino.
Con la sua garbatissima ironia, Iosif Brodskij scrisse che “ogni carriera letteraria inizia da un’aspirazione alla santità. Nel processo della creazione risulta, molto spesso, che la vostra penna sia di gran lunga più dotata di talento della vostra anima”. Naturalmente egli rivolgeva la propria amara celia al se stesso poeta, per primo. Brodskij sperimentava quotidianamente che l’essere umano tende ad ampliarsi sempre più, che la spinta propulsiva che dapprima vorrebbe riportarlo alla casa, agli affetti – parliamo propriamente di un esule – viene sempre di più sostituita da una sorta di squarcio integrale, dalla mano “slargatamente aperta” del Rilke delle Elegie. Brodskij voleva farsi coincidere tutto con il tempo, spingere dapprima sopra i corpi dei suoi lettori una sorta di carro armato di parole e, più tardi nella vita, attrarre quei corpi magneticamente, “senza alzare la voce”, verso un’apertura che non si può dire, ma semplicemente manifestare, suggestionando la materia con la musica dello spalancamento che fanno i versi. Un pifferaio magico.
“I versi”, scriveva, “non sono che il mezzo di trasporto della poesia”. Speriamo, verso un’ampiezza di sguardo che ci faccia pieni di “compassione”: e questa è la mia parola-ossessione.
Ma, ancora Brodskij, nel resoconto poetico del 1972, scrisse della perdita come del principio di eguaglianza tra Dio e i mortali (ecco perché, alla fine della descrizione degli impassibili oggetti, fa parlare la voce di Maria: la donna-oggetto di Dio, quella suprema lei, che si è fatta terra calpestabile per il passo del più invisibile tra gli invisibili). Anche Brodskij dilata il principio di uguaglianza tra la mortalità e il divino emblema della immortalità. E allora, se uomini e cose sono uguali e se uomini e Dio sono uguali, spingiamoci fin qui: Dio è la cosa e la cosa è Dio.
Tutti i grandi parlano di questa eguaglianza radicale, della equanimità dei viventi e dei non vivi (non più, non ancora vivi). L’arte ripete da millenni e nelle sue mille forme: tu sei Dio e sei una cosa, sei talmente una cosa da possedere perfettamente e inesorabilmente la perfettissima inerzia di Dio, la mancanza di moto del motore primo. “L’amor che move il sole e l’altre stelle di Dante”: perfettamente immobile, perfettamente umano.
Probabilmente l’esperienza amorosa e la fantasia religiosa, insieme al godimento delle arti, fanno migrare i non-poeti nel mondo che i poeti abitano quando sono “ispirati”. Forse possiamo definire la poesia uno stato di innamoramento nei confronti del mondo, della natura e delle sue creature. Ma un contatto incostante e indimostrabile altrimenti che con la poesia in sé. L’organismo razionale dei filosofi raramente sopporta questa mancanza di prove. Socrate definiva la poesia come “mania”, “ispirazione divina”, dimostrando una fede pregressa in qualcosa che sovrasta l’umano e al quale il poeta attingerebbe, quando l’ispirazione lo spinge fuori dal suo sé comune. Tanto è vero che: la creatura comune che il poeta è quando non poeta, non è in grado di produrre poesia. I filosofi hanno sempre fatto ricorso alle Muse, al divino e alle più fantasiose categorie ontologiche, per spiegare il contatto che i poeti vivono attraverso il corpo. Ma qui interessa ricordare anche la considerazione socratica sulla condivisibilità della forza poetica: essa si propaga a chi ascolta (o legge) per contagio magnetico. Socrate, Brodskij – ma anche Verlaine, il quale scrisse che la poesia è tale quando “ispira” chi la legge.
Eppure, i nostri poeti hanno progressivamente introiettato la sdrammatizzazione della propria figura, umana e sociale, e questa sdrammatizzazione informa la fibra della poetica contemporanea, che si attiene a levigare la superficie del reale, offrendone una vista piena di intelligenza e d’ironia. E di pudore.
Certo tutti dobbiamo levarci dall’imbarazzo di sentirci esuli, “ebrei”, per dirla con Marina Cvetaeva. E certo tutti ricordiamo Adorno e la sua considerazione intorno all’impossibilità (inopportunità, diremmo) di scrivere poesia dopo Auschwitz. La poesia veniva immaginata dal filosofo come un atto di barbarie. Sarebbe stato barbaro (insensibile, cinico) estetizzare l’orrore.
Ma la poesia non è estetizzazione. Tanto meno evasione dal reale. È, anzi, presa in carico.
L’intera, magnifica e terribile opera di Paul Celan smentì Adorno, sciolse immediatamente l’equivoco adorniano sulla poesia. E cambiò anche la poesia, costruendo con essa una nuova fiducia, davanti all’evidente inconsistenza di Dio: fiducia nella parola e nella risorsa umana di cantare, al di sopra di ogni insanguinata corona: “per la parola di porpora / che noi cantammo al di sopra, / ben al di sopra / della spina”. Siamo nel 1963. Con il suo esistere, Celan smentisce anche il saggio di Jean-Paul Sartre contro la poesia non engagée (Qu’est-ce la littérature?, Gallimard, 1948), apprezzabile se lo storicizziamo, poiché scritto in quei tempi di tragico, umano disincanto, da un uomo che, coerentemente, non aveva più lavorato alla miniera poetica che possedeva (si pensi alla Contemplazione della maternità di Maria, che egli scrisse dalla prigionia, si pensi a quanto sia rivelatore di un attaccamento paradossale, il denigramento sartriano della persona-Baudelaire, agito proprio mentre si occupava del poeta-Baudelaire).
Ma altrettanto smentiscono Adorno l’ebrea olandese Etty Hillesum, che, come l’ebrea tedesca Gertrud Kolmar, davanti a una reale possibilità di salvezza, scelsero di rimanere accanto al proprio popolo e ai propri affetti. Entrambe morirono in Auschwitz nel 1943: essendo passate attraverso la paura e il dolore e avendo trovato una emancipazione personale da questa paura e da questo dolore. Ecco infatti Hillesum: “Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio, nell’anno del Signore 1942, l’ennesimo anno di guerra”. Etty Hillesum e Paul Celan sono riusciti a cogliere quel filo d’oro che ci conserva vivamente vivi, anche dentro uno dei più vasti orrori umani. Perché i poeti, come tutti, in tutti i tempi di guerra, si trovano a dover conciliare il proprio mondo interno con un orrore che pare disumano e invece è umano. Celan risolse il problema da suo pari. Dichiarando il bisogno di credere al bene. Comunque. E a nome di tutti.
Ma chi sono questi esseri che vedono oltre l’orrore? Fanciullini pascoliani. Idioti dostoevskiani. Ovvero persone che hanno scelto di mettersi all’opera per contrastare l’inferno calviniano, forse coltivando la guarigione di un’antica ferita, che si è fatta patrimonio umano, collettivo. Persone che lavorano quotidianamente su una inclinazione naturale alla sopravvivenza. Questa specie di poeti abita, da alchimista, una propensione a trasformare in bene – o almeno in bellezza – ogni dolore (comprendo che le categorie di bellezza e di bene echeggiano interminati dibattiti estetici e letterari, ma – appunto – confido in un intenderci più immediato). Perché? Cosa li muove? Sono bambini incapaci di sopportare la dura realtà, che raccontano elaboratissime favole per adulti, intelligenti come sono, ma rifugiati in un pensiero magico e infantile? Oppure?
Rimanendo nella metafora del corpo sociale, direi che sono le fibre che si mettono al lavoro per riformare i tessuti dopo un trauma. Inflitto non solo al linguaggio, naturalmente, poiché la parola è emanazione diretta del corpo sociale che la pronuncia, ne rivela le viscere e i retropensieri, tutto l’inconfessabile e il non detto. Che bisogno ci sarebbe stato, altrimenti, di chiamare “pezzi” altri esseri umani? Ebrei, omosessuali, zingari: ingombranti scarti di falegnameria, da smaltire con intelligente efficienza.
Di cos’altro è deriva, infatti, la devastazione morale che conduce al delitto (di massa, in questi casi) se non dall’incapacità di riconoscersi nell’altro essere umano, di sentire quell’altro più di un fratello, come un altro sé? Quel provare la pena di un altro e il desiderio di restituirgli pulita quella pena, passata dentro il filtro di uno sguardo proprio, che ne abbia distillato la più recondita bontà. Per questa specie di poeti fare poesia è politica, è una prova di r’esistenza a oltranza sulla superficie della terra. L’ho già scritto, in un articolo apparso su “il manifesto” del 17 luglio 2011.
Questi poeti ci ricordano che siamo piegati a vivere in un mondo che non corrisponde alla nostra natura più profonda, libera e vera. Ricordano e ci ricordano che il mondo non ci corrisponde, non corrisponde alla gioia alla quale abbiamo diritto. Dico dell’Occidente – ma, della contemporaneità, privilegio la coraggiosa eversione della parola delle poetesse arabe – dico di questa ridicola struttura che ci vuole tenere impegnati fino alla morte in fatti che non ci riguardano. Perché altrimenti ci ricorderemmo che siamo destinati a morire e smetteremmo di perdere il breve tempo della nostra vita a fare cose che non ci fanno felici – o che, peggio, imprigionano altri. Perché altrimenti vedremmo l’organizzazione normativa che guida questa nostra piccola parte di mondo per quel poco che è: una rassicurante bazzecola. Quella sì, infantile. Quella sì, una galera. Fondata sul potere e sull’economia, quando non su (apparentemente) irrisorie questioni di genere. Basta scavalcare un confine geografico e cambiano le leggi. Convenzioni di buona creanza. I poeti vedono la realtà. Ma la combattono, fanno resistenza. Perché vedono la bellezza e la bontà permanenti, non l’occasione della loro disfatta. Credono all’invisibile umano. La loro vita è testimonianza di quel mondo che comunemente non si vede – o si vede a barlumi.
L’arte, infatti, è un’espressione umana che dura da più tempo di qualsiasi religione terrestre. Perché la religione è la favola che traduce in formula dogmatica e comunicabile quel che gli artisti sanno. Lo scrive tanto bene anche un illuminista come Freud. Il primo uomo (o donna) primitivo che ha fatto un gesto non finalizzato alla sopravvivenza del corpo, un disegno sulla parete della sua caverna, ha detto di quel mondo parallelo, di quel bisogno. Che pare superfluo. E invece no. Ci vuole coraggio, per mantenere viva la fiducia nella bontà degli uomini e della natura, nei legamenti segreti fra le cose e fra creatura e creatura. Che non significa non vedere quanto della realtà contraddice la nostra natura.
Ci vuole coraggio, per non cedere a quella che pare evidenza e non è che la superficie delle cose. I poeti vivono di disegni sulla parete della propria caverna. Che forse dureranno quanto la caverna stessa. O forse no. L’importante è che il gesto sia tramandato. Perché quella pur disincantata illusione è la vera forza umana.
Inoltre: che il PoetaX parli sempre di un’assenza e da una lontananza è condizione indispensabile e non “disingaggio”. Tutt’altro. Da quel solo seme nasce la poesia, anche quando è imbevuta di psicoanalisi, realismo e finanche minimalismo, come nel Novecento europeo. E ognuno risolve come può quella perdita primaria, che è di tutti: chi ponendosi in contrapposizione al mondo (Bukowski e tutti i commilitoni beat), chi isolandosi in sé e diventando irraggiungibile a chiunque, chi decidendo di vederne comunque la malinconica bellezza, chi votandosi alla ricerca della gioia come un rabdomante, per sanare e sanarsi (qui l’elenco è infinito. Due per tutti: Ted Hughes e Dylan Thomas). Questi ultimi (alla compagnia dei quali mi alimento) praticano un gramsciano “ottimismo della volontà”. Ma anche il susseguente, indispensabile “pessimismo della ragione”, perché vivono la fatica di conciliare questo genere di esperienza con una struttura sociale sempre più competitiva, con le contaminazioni di una materia ottusa che ci ingloba (l’inferno calviniano, ancora).
Dunque, il Poetaquieora deve essere in grado di sopportare non solo una mancanza originaria, ma anche una mancanza di senso originario, e deve avere in sé la forza e la fiducia bastanti per ribellarsi alla falsificazione e alla espropriazione del linguaggio, deve provare a rimettere ordine fra i nomi o praticare effetti-paradosso, simulando i linguaggi della merce. Il Poetaquieora deve affrontare il disordine alfabetico e rinnovare le parole, immettendo in esse il contatto elettrico perduto, che riformi il – più che rimandare al – senso unitario dell’esistenza.
Scrive Antonella Anedda, in uno dei suoi tanti testi corali: “Se ho scritto è per pensiero / perché ero in pensiero per la vita / per gli esseri felici”. E ancora: “Scrivi perché nulla è difeso e la parola bosco / trema più fragile del bosco”.
Ma ecco la recentissima risposta di Jean-Luc Nancy in Prendere la parola. Ormai, scrive il filosofo, ci è permesso raggiungere quello che chiamiamo “essere” solo a frammenti, a bagliori. Siamo stretti a trascrivere apparizioni brevi (quanto rinnegate) di quello stato plurale e originario, naturale e collettivo, dell’essere che conteniamo. La nostra società è fissa su una negazione proliferante, su una continua distrazione, perché l’Occidente non sa portare l’idea della propria morte. Taluni si tengono occupati con Dio. Altri, con la Legge. Altri ancora, approfittano del tempo che sono vivi per lasciare che il loro io defluisca nelle profondità di ciascun oggetto del mondo. Hanno, nelle proprie parole, il mezzo e l’antiveleno, per lasciare che “io” diventi “mondo”: barra automatica, lampione, cane e circostanza. Forse sono già scomparsi.
Come ho scritto commentando il film perfetto In the mood for love (A+L n. 15, 2010): “il mio amore è una lingua straniera nata da me”. Valga lo stesso per la poesia. Con l’intenzione sempre più evidente di scrivere in diretta della gioia che ho detto, del festoso dilapidarsi dell’io. “Al cielo piacendo”, come salmodiavano le brave donne. Però io lo farei per piacer mio.
Maria Grazia Calandrone
Roma, 25.1.2015

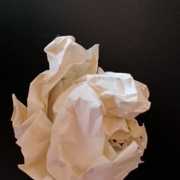


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!