Dante, Vita Nova (IULM, 5.4.11)
Dante o il contagio dell’oltrepoesia
Commissionata di una presentazione delle Opere di Dante, la prima notte dopo aver letto le pagine iniziali, fino al sonetto Cavalcando, della Vita Nova, alle ore 6.50 del mattino ho avuto un sogno. Al principio c’erano cani e altri scabri animali da cavalcatura nei luoghi del sangue e dei rituali del primo amore e bestie alte e sfrenate e comparse e scomparse attraverso tutti i secoli – e qualcosa rideva dal sorriso di tutti gli amanti, volgeva in direzione della gioia e davanti ai miei occhi passavano figure benedicenti e bendate fino alla signoria di una forma seduta verso la quale il mio corpo provava una fedeltà bruciante e mi lasciavo cadere ai suoi piedi e dicevo parole come isfindigada et iscravamentu, ovvero le parole del parto e della crocefissione nel nostro italiano più arcaico, le parole che dicono il compito massimo di donna e uomo: lei genera vita e lui la conserva assumendosi il male – e il mio essere donna era fenomeno di occasione, ero stata uomo e donna attraverso tutti i secoli ora ero involucro potentissimo d’amore. Le creature relative a me nei secoli non erano che imagines per sviluppare in questo io occasionale la fiamma dell’amore, non mi era mai stato così chiaro e io piangevo di riconoscenza perché la meta di tutte le vite è questo incontenibile ardimento d’amore. La meta di tutto è una sconfinata scorporata fiammeggiante gratitudine. Nel sogno capivo cosa altri chiamassero dio.
Ore 6.50 del 19 marzo 2011. La somma di questi numeri è 10, Uno.
Ecco. È andata così: quando mi sono trovata questo libro tra le mani ho provato la leggera vertigine che precede le scalate montane, le sfide della iperventilazione. Ho aperto subito la Vita Nova, ho letto una diecina di pagine, ho richiuso, ho visto la televisione e ho sognato il sogno che ho detto. Nei giorni successivi leggevo una pagina di Dante poi mi alzavo dalla scrivania e buttavo via libri di poesia. Così procedendo ho sgomberato mezza libreria. E avrei fatto di peggio: pochissimi mi sembravano degni di stare sugli stessi scaffali. Poi il bisogno di ordine ha esondato dagli scaffali: ai divani, ai tavolini. Moltissimi sono stati i naufragi, i banditi e i temporanei esili. Il risultato è stato il nitore di molte superfici.
Tale è il dinamismo delle parole di Dante. Serve a fare aria in casa. In senso fisico e in senso vivamente metaforico.
E tale ne è l’utilità. Il primo affetto è il riordino della scala di valore, come se finalmente si presentasse a noi il termine di confronto, il faro nell’oceano della prassi poetica contemporanea.
Certo Dante avvalora e ridimensiona. Vale per noi quel che scrive di sé: lo si immagina quasi, naso a terra, mentre fiuta le tracce della pantera del volgare, lo figuriamo perso dietro quella astrazione così muscolosa e piena di afrori nata dalle sue stesse parole. Ebbene, noi strisciamo fiutando le tracce di Dante, perché egli stesso si è posto come misura: numero 1, il bianco, la cosa che è la più semplice, padre-“matrice” della poesia. Non un esempio. Dante è una Utopia – eper ciò riesce a esporsi come una meta senza inibirci, tanto: lo sappiamo da subito, che non saremo lui. Ma.
Egli dice di sì alla compresenza di legami inauditi, l’intero suo discorso è compresenza: autorizza con il suo esempio arroganza e umiltà brucianti, egotismo quasi livoroso e il più generoso comunismo, mette il bollo della sua autorità su parole covate dal caldo dell’embrione alla più aspera connotazione logica.
Solo un uomo con questo vissuto interiore quasi incontenibile di macrocosmo e microcosmo (diremmo di macro-io e micro-io) poteva afferrare le minime vibrazioni occasionali dell’aria che in strada e nei mercati si andava facendo parola per sollevarle a celebrare Dio. Perché la febbre dello strumento preesiste alla parola, forse si tratta di una forma perturbata di ascolto che trova anzi salute e ordine nella parola. Il corpo della lingua è l’organismo vivo che si addiziona al corpo del poeta, tradotto anch’esso in verba, poiché Dante è la prima figura letteraria di Dante, è il suo laboratorio, il suo principale oggetto linguistico, disordinato da ciuffi di energia allo stato libero: tutta la lingua ha una vivacità fisica e una irrefrenabile efficienzapropulsiva. Il corpo del poeta sta in piedi sul carro in fiamme delle sue parole e, anche mentre lo governa – o forse soprattutto mentre doma i cavalli coi ferri della logica, patisce ferocemente l’emorragia razionale della nostalgia. Nel caso di Dante, come sottolinea Santagata ad apertura, l’organismo dell’opera è pieno di autocitazioni, legamenti che lo rendono de-scritto nel suo farsi – e anche il pensiero è in pieno mutamento e maturazione: Dante si può permettere di preannunciarsi, di contraddirsi, di domandare scusa e usare di quest’arte quasi divina per levarsi qualche sassolino dalla scarpa.
Questo perché con ogni probabilità a Dante il mondo compare spontaneamente organizzato in parole. Dal primo all’ultimo svenimento [– l’arco voltaico tra lo svenimento iniziale all’arrivo di Beatrice e quello finale alla vista di Dio, che sottolinea Santagata –] alla definitiva personificazione di Amore che parla, colonizza gli occhi amati e per quel tramite origina l’ammirazione del creato: Beatrice è il Cristo che sparge il suo miracolo. In silenzio. Solo con gli occhi.
Ovvio che Dante è nebulizzato in tutta la poesia venuta dopo di lui, ma – data la sua enormità – compare appunto parcellizzato: qui con le sue visioni, là con il suo modus amandi – per assimilazione o per contrasto – altrove con le sue petrosità…
Molto Dante è, per esempio, nella dedica purgatoriale di Caproni Il seme del piangere: suo straziante requiem per la madre-fidanzata cantato in forma di filastrocca apparente, sta in quei versi pregati di andare presso l’amata, a inginocchiarsi ai piedi dell’amata come veri e fisici messaggeri d’amore, sta nella leggerezza chiara appena smentita dal poeta stesso.
Questo è soltanto uno degli esempi quasi a ricalco, ma leggere Dante equivale a lasciarsi contagiare dall’oltrepoesia, è come leggere la storia alla luce delle origini, al lampo del big-bang che ha espanso nella poesia successiva la polvere roboante e luminosa di ogni stella, di ogni propria sostanza. Ma.
La poesia contemporaneissima – diciamo, per capirci: dalla “scienza poetica” di Zanzotto quanto alla lingua e, quanto alla sostanza, da Anedda – tende a farsi antilirica e sempre più torna a occuparsi del mondo e delle sue istruzioni e sapienze mondane – e desidera (lo desidera sempre più sanguinosamente!) incidere il cuoio del mondo con il pirografo delle parole, intervenire con i suoi ultrasuoni: è reattiva alle cose, vibra di carica civile .
Fatto sta che, nonostante l’affinità con la modalità dantesca, nessuno tra i poeti contemporanei confesserebbe di sentirsi un profeta. Il vomere agostiniano della profezia viene spinto in silenzio nella terra viva del proprio corpo o è spezzato da un freddo disincanto, è un attrezzo abbandonato alla pioggia del disuso. Ma Mandel’stam. Ma Rosselli. Lei: visionaria, stilisticamente originaria, ovvero fondatrice di se stessa, evocatrice di angioli assai più fisici di quelli rilkiani, che erano volati nel frattempo nel cielo della grande poesia insieme alla lacuna di Maria – che tremava tra le altissime compassioni prima di venire accolta dal Figlio – come qui la mancanza di Beatrice, che rappresenta il solo difetto celeste. Queste mancanze sono quelle che congiungono la terra al cielo, queste rappresentanti del cielo in terra sono anche la nostalgia che il cielo ha della terra. Dante si è espanso fino a sentire la malinconia del cielo per la propria astrazione di cielo.
Una consunzione di amore fisicamente quasi insopportabile, ma che Dante sopporta. Perché? Perché questo suo amore gli permette di scrivere – se la incapacità di dire d’amore è nelle Rime più grave della morte d’amore. Anzi: sola consolazione e beatitudine dell’amore è scriverne lodando la donna amata così come comincia a fare nella canzone Donne ch’avete intelletto d’amore.
Eppure, devono accumularsi fatti e buone ragioni perché Dante decida di mettersi a scrivere. Così ci insegnerà anche Rilke, che bisogna raccogliere senso ed esperienza per tutta una vita per scrivere, alla fine, dieci versi buoni. Dante precede il metodo: raccoglie eventi, cose, fatti veri – e aspetta fin che le parole si formino e fiuti in loro la miccia della necessità.
In condizioni di normalità la ruota di tutta questa bellezza è fisicamente insopportabile. Ma Pasolini pone la lettura dantesca nelle carceri di Mamma Roma. Pasolini trasse probabilmente ispirazione dalla storia, perché Dante veniva effettivamente letto nei campi di concentramento: quelli di Tito e nei lager nazisti: dove tutta la bellezza era bruciata, sepolta, torturata, Dante era ristoro. Fu Dante stesso, del resto, a chiarire che scrisse la Commedia per rimuovere quelli che in questa vita sono in stato di miseria e condurli allo stato di felicità.
Forse solo un uomo tanto gigantesco e infebbrato riesce a farsi vicino a tanto dolore, perché più un poeta (un uomo) è grande più ha la facoltà di diventare davvero altro da sé, di “immedesimarsi” e, soprattutto, di essere, oltre che un io compresente in tutti i propri stadi evolutivi, anche una compresenza di creature.
Nella ispirazione – legato a un io particolare solo dalla necessità di non perdersi – il poeta ha un io corale e morale: più è grande più è collettivo. .
Dante è così limitrofo a se stesso e insieme così altro da una creatura umana, con questo io che ha rotto gli argini ed è quasi infinito, quasi vaneggiante ma razionalissimo, scisso tra la sovrascrittura delle ragioni del suo dire e la trascrizione di quello che egli stesso chiama farneticare, ovvero la realtà inconfutabile – perché essa si accende solo per esperienza e dunque per fede – alla quale egli accede nei sogni notturni, nelle visioni. Dante usa i ferri del mestiere sotto il sole: così prepara la logica stringente della Commedia, quel misto irripetibile di storia e delirio organizzato, perché è sisma e sismografo nello stesso momento, registra in diretta i mutamenti della lingua e ne produce a sua volta con una spinta propulsiva rivoluzionaria – soprattutto nel mescolare i generi – che non ha più avuto pari.
È senza dubbio uno degli effetti di un pensiero gigantesco ma altrettanto certamente sono gli effetti delle parole: chi si mette sotto il governo delle parole non sa mai dal principio dove andrà a finire.
Qualunque cosa ne dica Dante la parola “detta” nel senso della comunicazione tra esseri esordisce nella Genesi come atto diabolico: nella domanda insinuante, paradossale e ironica che il serpente rivolge a Eva. Questo è comprensibile perché dover dire parole presuppone una separazione, fosse anche solo, come dice Dante stesso, dovuta alla opacità del corpo mortale. Fino a quel momento Dio parlava da solo (o con il suo creato, che è lo stesso) incitando se stesso alla creazione e Adamo dava nomi – agli animali e alla donna – e con Eva appena nata e tutta santa non sentiva il bisogno di parlare. Ma ecco il diabàllo della comunicazione, il Nemico, la solitudine.
Certo: anche scrivere presuppone una separazione, ma insieme è un atto d’amore e di fede, un gesto rivolto necessariamente al futuro. Nell’atto di scrivere è implicito il sentimento di un tempo che non smette, di un dopo – fosse anche tra un minuto, anche se tu mi leggi tra un minuto – che verrà. Scrivere dunque ha a che vedere con il sentimento del tempo e della realtà, ovvero con una solidissima certezza del mondo reale, con una certa sua praticaccia, altrimenti ci si consumerebbe in estasi senza parola come le sante, anch’esse dirette nel loro mutissimo sentimento a un destinatario invisibile. Chi scrive invece deve avere fede nel futuro – e che questo futuro formerà gli occhi visibili di un destinatario attualmente non visibile: verrà qualcuno che leggerà queste tracce, questi segni veri, con occhi veri.
Questo non è un gesto infantile. Ma è un gesto innocente.
Più leggevo più mi tornava alla mente una frase sentita per strada anni fa e che non ho più dimenticato: una signora anziana diceva a un’amica: “lui si è fatto vedere perché lei era un’anima innocente”. Parlava di Dio – o di un morto. Ebbene, Dante possiede il connotato della “innocenza”, è come un lineamento del suo volto: la sua sapienza, virile e spaventosa, la dolcezza fisica di certi suoi versi, la sua ostinazione, la confessione del tradimento, il pentimento: tutto in lui tende verso l’“innocenza”. Si tratta anche, certo, della innocenza che l’esule vuole gli venga politicamente riconosciuta – fino all’assurdo di inventare per se stesso una immaginaria nobiltà di sangue – ma si tratta soprattutto della innocenza ontologica del vate volgare, che vuole recitare il mondo nella lingua del mondo. Quella di Dante è una leva di parole, una barra di energia d’acciaio volta alla rifondazione del mondo che vuole quasi cancellare la scucitura tra cosa e cosa.
Certamente senza la sconfitta politica subìta Dante non avrebbe avuto bisogno né modo di allargare tanto lo sguardo, né forse si sarebbe messo a desiderare un tanto sublime riscatto spremendo da sé tanta grandezza. Sul desiderio di autoaffermazione di Dante insiste molto anche Mandel’stam, che vuole intelligentemente prestar fede alle parole di Dante personaggio della Comedia continuamente salvato da clamorose gaffes da Virgilio – altrimenti, con Dante da solo, Mandel’stam lascia intendere che la Comedia avrebbe avuto i connotati letterali della commedia grottesca.
Il troppo umano nietzschiano al cospetto di Dio fa venire da ridere, susciterebbe l’ilarità di Dio.
Eppure, quell’arrogante umilissimo ipocondriaco geniale “giullare” è nella nostra lingua quotidiana, nell’ossatura pure tutta ripetutamente rivoluzionata della nostra lingua, è lo scheletro inconscio di chiunque si arrischi a mettere penna su carta. Si porta Dante come si porta nelle vene il sangue degli avi: mischiato al nostro è cosa che si fa nuova e muove nel sé tutta una indecifrabile sapienza, così che cavarlo via sarebbe come amputarsi la mano che scrive, abbattere le macchine volanti di tutti i versi venuti dopo di lui e anche accecare la nostra coscienza del presente perché, come scrive Mandel’stam, i canti di Dante sono armati per percepire il futuro.
Dante, insomma, ci ricorda l’importanza della lingua come legante di una comunità umana nel tempo e ci ricorda che la poesia è un’ala profetica di questa comunità ed è forse ancora il suo gesto più civile, il suo raffinamento e la sua decantazione in previsione di altri, che sono e che verranno: la lingua dei poeti fonda la lingua della comunità nazionale, la lingua sociale.
La necessità stessa della locutio, che dalla sua origine [– per quanto Dante manipoli le sacre fonti per sostenere la parola come massimo dono ricevuto da Dio –] rivela insufficienza e solitudine umane, assume forse con la poesia, oltre alla funzione politica pura che abbiamo descritto, una seconda potenza: esponenziale: riporta la parola a un grado di comunicazione edenica, poiché la poesia comunica più con il silenzio tra le parole che con i segni espliciti del discorso. Lo sappiamo, l’opera è l’involucro, il corpo opaco della materia poetica, è la mera sequenza di lettere che ci permette di eseguire ancora quel silenzio perfetto che ci unisce più intimamente dell’opaco, di ogni gioioso stormento e di tutte le declinazioni della nostra pur agilissima eloquenza.
29.3.11
***
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Università IULM istituisce il Dipartimento di Italianistica. È questo un ulteriore contributo che l’Ateneo porta al processo di valorizzazione della lingua e della cultura italiana.
L’annuncio della nascita del nuovo Dipartimento simbolicamente si gemella alla presentazione del primo volume delle ‘Opere’ di Dante (Rime, Vita Nova e De Vulgari Eloquentia) curato da Marco Santagata e edito da Mondadori per la collana I Meridiani.
11.00 – 11.10
Presentazione del Dipartimento di Italianistica e introduzione ai lavori
Giovanni Puglisi, Rettore dell’Università IULM
11.10 11.50
Presentazione del primo volume delle ‘Opere’ di Dante (Rime, Vita Nova e De Vulgari Eloquentia) – I Meridiani, Mondadori Editore.
Intervengono:
Salvatore Silvano Nigro, ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea e direttore del Dipartimento di Italianistica – Università IULM
Gian Luigi Beccaria, ordinario di Storia della Lingua Italiana – Università degli Studi di Torino
Maria Grazia Calandrone, poetessa
Modera:
Francesco Sabatini, Presidente emerito dell’Accademia della Crusca, già ordinario di Storia della Lingua Italiana – Università Roma Tre
11.50 – 12.00
Sonia Bergamasco recita una selezione di versi danteschi
Sono presenti gli autori del libro: Marco Santagata, Claudio Giunta, Mirko Tavoni

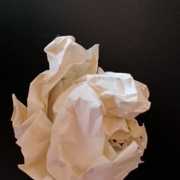


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!