Pugno Laura, La ragazza selvaggia / bianco (alfabeta2, almanacco 2017)
Laura Pugno. Il bianco, l’aperto, l’animale – ALMANACCO 2017 alfabeta2 e “alfabeta 2” 7.7.16
Il bianco della solitudine ma il bianco della poesia
In questi primi mesi del 2016 Laura Pugno ci offre la poesia di bianco, uscito in marzo per nottetempo e la prosa de La ragazza selvaggia (Marsilio): due libri che possono essere letti uno come il rovescio dell’altro.
Le figure che si muovono nell’opera di Laura Pugno sono sempre estremamente sole, diremmo anzi che siano governate da una solitudine estrema, che dètta loro scelte esistenziali (nel romanzo: andare via da tutto, tagliare i ponti, sparire – oppure abbandonare, lasciar andare) interrotte da rari, occasionali contatti con altri esseri, altrettanto soli e perduti dentro l’ottusa crudeltà del caso. In tutta l’opera di Pugno il clima è torrido – o gelido – e la natura è totale, a significare l’insignificanza di quest’umano, che porta la sua risata come il blasone della propria specie.
Inoltre, tutte le coordinate spaziotemporali si curvano fino a coincidere: fino a una preistoria del futuro, a un’atmosfera da fantascienza primordiale.
La solitudine de La ragazza selvaggia sembra però risolta per magia da un legame eccellente, che manda a rotoli scienza e ragione: il vincolo di un doppio gemellare, dimostrabile solo nei suoi effetti misteriosi, ma che non è neppure vera alterità, piuttosto quasi lo scindersi di un unico corpo, tanta è la coincidenza invisibile e muta tra le gemelle, tale lo scambio di energie vitali.
Le gemelle Dasha e Nina, venute da un altrove remoto, queste belle irruzioni di un panorama estraneo nella vita dell’alta borghesia romana, sembrano lentamente imparare una felicità fatta non solo di agio del corpo soddisfatto, nutrito e caldo, ma anche di una vicinanza sentimentale, che però non arriva a entrare nel nucleo profondo e impenetrabile dei loro affetti. Dasha e Nina sono una microcomunità, un binomio assoluto, una bolla di spaziotempo interrotto, sono incarnazione del tempo diviso – e però duplicato; irrecuperabile – e però irrimediabile, come il freddo di un infanzia crudele impresso per sempre nella carne adulta.
Il ribrezzo che provano altri è la parte emersa dell’ossessione, il tentativo disperato di autodifesa.
Ma l’incanto non è davvero incanto: nella sfera magica c’è la tensione assoluta di un antagonismo immobile, tanto feroce e dissipante pare la loro lotta, un pietrificato: muori perché io viva.
La morte è un semplice “dissipare calore”, viene detto. I led sul crinale della montagna, che nella prima pagina del libro appaiono come sola divinità possibile, vengono in fine associati alle luci delle candele che si lasciano accese per i morti, accanto al pane. Questo è dunque il sentimento del divino, dell’oltre terreno, di qualcuno che torna per amore. Meglio: che torna perché trova amore, ancora. Sotto forma di pane e memoria.
“Sarebbe stata felice come una che ha attraversato il dolore”, viene anche detto. Come una che abbia attraversato la morte e l’abbandono, ci spingiamo a dire, dirigendoci verso il bianco della poesia, che sembra essere il rovescio commosso del romanzo, la sua scoria luminosa e, contemporaneamente, la sua traccia sommersa. Anche qui, c’è la figura umana nella neve, ma la muta ferocia del romanzo ha pace, questa neve è biancore luminoso. I morti sono stati abbandonati anche in poesia (“nessuno / più versa vino a terra per i morti”), ma dolcemente – anche nella poesia si aggira una creatura di neve, una figura lunare, dalla pelle chiarissima, qualcosa o qualcuno, una forma che cerca una casa, che deve tornare.
Ma “ognuno muove appena / quello che di sé è vivo nel mondo”, dunque questa creatura senza casa, con la remota memoria di una casa e di un’infanzia, che forse ha bruciato la più profonda fibra della sua carne, siamo tutti noi, è ogni essere umano che da vivo desidera tornare, come quello che nell’ottava elegia di Rilke si volta a guardare la sua casa: “Ma chi ci ha rigirati così / che qualsia quel che facciamo / è sempre come fossimo nell’atto di partire? […] così viviamo per dir sempre addio.”
Quella di Laura Pugno è dunque la dichiarazione di un esilio collettivo, che in prosa è una feroce solitudine di bestia che verrà nuovamente abbandonata al suo stesso abbandono – e in poesia trova invece una soglia, un bicchiere di latte, una terra da far splendere con i propri passi e, soprattutto, una socialità, il sentimento di un gruppo umano che si muove e fa cose collettive (“comunità che fa crescere le piante”) e, alla fine, assiste al ritorno: “chiunque abbia occhi / ti vedrà tornare”.
L’esule deve rinunciare al bianco perfetto della neve, alla pace perfetta della neve, alla sua solitudine perfetta, per far parte della comunità e, se possibile, mantenersi per sempre sul bilico celaniano della soglia tra dentro e fuori, tra tasche piene di neve e invece latte e pane caldo e conforto.
La doppia opera di Laura Pugno è dunque descrizione di un confine, di uno stato di esilio che si scioglie come neve e di una solitudine che viene consolata con offerte. Solitudine di vivi e solitudine di morti, che avranno ancora sul tavolo la loro tazza colma di bianco, tanto è labile anche questo confine apparentemente estremo tra vita e morte, tra passato e futuro, tra io e mondo, tra questo fuori bianchissimo e questo altrettanto bianco cuore, che riportiamo al caldo delle case e tra i fuochi domestici, tra coloro che “contano covoni e capi di bestie”, tra “quello che è donato e che è perduto”. Il baratto, lo scambio, la lontananza. E il calore animale: “e tutto quello che è animale / è vivo, è vivo”. Vivo è l’animale e bianca è dunque la poesia, che sgroviglia l’intricata solitudine animale e boschiva di Dasha, della creatura abbandonata da chi dovrebbe amarla come se stessa, poiché ne è il doppio. Entrambe provenute da un non-luogo, Dasha e Nina non solidarizzano. Se la protagonista del romanzo non è la ragazza selvaggia del titolo, ma colei che l’abbandona e dunque tiene nelle sue mani il capo della trama romanzesca, protagonista del bianco della poesia è la figura che torna o che vuole tornare, che rinuncia a qualcosa della propria splendente solitudine per fare parte di un cerchio caldo di animali umani.
Sappiamo che Laura Pugno desidera tenere separate prosa e poesia. Forse ora comprendiamo il perché: la poesia sembra essere il distillato, la figura alchemica della sua prosa, il frutto lavorato del dolore e della solitudine che spingono e premono, con toni anche horrorifici, sotto la bella pagina piena della sua prosa. In poesia c’è aria, c’è spazio e luce, un “tu” rimarginato e non più o non solo emarginato, c’è qualcuno che parla e dice “vedi, che hai fiducia, / nell’aperto”.
Ci prendiamo l’arbitrio di estendere queste osservazioni alla funzione della poesia: diciamo che la poesia è il frutto del dolore attraversato, il lasciapassare per una gioia più profonda. Se la prosa è il racconto del viaggio, la cronaca di un attraversamento di terre oscure e luminose come boschi, la poesia è l’Aperto, ancora una volta rilkiano, quello che l’animale guarda “con tutti gli occhi”, la meta bella e soprattutto – ma ci vuole tanto tempo, per capirlo –: condivisa.

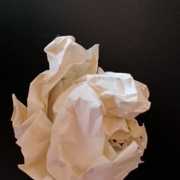


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!