Szymborska Wislawa, omaggio a (Corriere della Sera, 25.7.16)
Corriere della Sera, 25.7.16
UN LEGGERO SORRISO DISPERATO
Grazie al mio lavoro vengo in contatto con la parte migliore e più viva del mondo: con quelli che nutrono (in senso proprio alimentare) speranze – spesso: utopie –, con quelli che si danno quotidianamente da fare per combattere l’insufficienza della realtà (operatori sociali e culturali, insegnanti che lavorano a un futuro sociale onesto, artisti che condividono con generosità il proprio slancio verso la salutare bellezza del mondo, lettori che si impegnano a indagare la realtà con l’aiuto delle parole altrui). Una specie di piccolo paradiso trasversale fatto di donne e uomini in grado di condividere e sperare. Poi, ci sono gli altri.
Più invecchio più trovo immorali, tetri e volgari il disincanto, la cultura del complotto, la sfiducia nella gestione della cosa pubblica, il qualunquismo. Siamo qui per costruire il futuro di quelli che verranno dopo di noi, non per difendere la deprimente scheggia di io-io-io che altrimenti ci abita e vorrebbe tristamente contagiare chi invece ogni giorno cerca in sé la forza di edificare un tempo nuovo.
Vade retro, delusi dalla vita! Vade retro, detrattori di speranza!
Come scrive Szymborska, in SCRITTO IN UN ALBERGO: “Nel quotidiano credo alla durata, / alle prospettive della storia. / Non riesco ad addentare le mele / in un continuo orrore”. Lo stesso che affermava Ian McEwan in Sabato: abbiamo a disposizione solo una certa quantità di compassione, non possiamo commuoverci per tutto, sopportare tutto. La speranza è la nostra salvezza. Ma non una speranza bambinesca e cieca, piuttosto la speranza di quelli che sanno sopportare il peso della delusione, del dolore e anche della disperazione comune e rilanciarne nuova bellezza. Tra questi, nel Novecento: Paul Celan e Wislawa Szymborska.
Ciò che si bacia, nella metrica concreta di Szymborska, sono a volte le rime, interne, AABB o ABA. Ma si baciano nella sua poesia cielo e terra, al punto di confondersi – e si baciano, in totale fusione, le creature. Anzi, meglio: il creato e l’increato, il mobile e l’inanimato. Szymborska ci presenta un mondo effuso, dove ogni cosa è uguale a ogni altra cosa, parimenti importante: l’ombra al corpo che la proietta, l’animale e l’umano che si osservano, il cielo alla sua pietra e l’immobile pietra al metamorfico cielo che la copre e, chissà, la custodisce e tiene.
La poesia di Wislawa Szymborska mi ha ricordato, da subito, la levità levigata e dettagliata di Katherine Mansfield, grande amore della mia giovinezza. La cifra della sua poesia è la naturalezza, la stessa naturalezza del canto che Szymborska dichiarò di ammirare nella bellissima voce fluida e senza sforzo di Ella Fitzgerald. In certi altri momenti Szymborska ricorda Gertrud Kolmar e i suoi mirabolanti inni domestici. Vedere l’infinito in una cucina. Vedere l’infinito in un corpo. Ma attenzione! Szymborska non mette all’opera l’evasione di una fantasia sfrenata, le sue sono sempre catene di associazioni logiche. Inconfutabili, scientifiche, ma assolutamente libere. Il segreto di questa poesia sta nella libertà associativa, non nell’immaginazione. Szymborska non ha bisogno di compagni invisibili, di amici immaginari, né di voli pindarici. Potremmo infatti dire che Szymborska sia un “anti-Pindaro”: a lei basta la terra, perché ha la capacità di stare sulla terra spremendo dalle cose della terra ogni stilla della loro bellezza, riconoscendo (inquadrando e restituendo) a ciascuna cosa il proprio senso (probabilmente nessuno) e la propria bellezza, la propria immancabile quota di stupore originario: alle pietre, alle rocce, alla cipolla (occasione per irridere “l’idiozia della perfezione”), a un melo e alla scimmia (dove troviamo zone di addensamento del linguaggio e della portata concettuale), ma anche a un insetto ordinariamente ma ordinatamente morto, in VISTO DALL’ALTO.
La morte di uno scarabeo ci ricorda la morte della blatta, nella quale GH, protagonista del romanzo sulla passione di Clarice Lispector, vede l’essenza neutrale di Dio: in quel bianco sangue che cola, muto e neutro, dal corpo dell’insetto, dalla piccola morte non compianta. La disperante neutralità di Dio, dunque la neutra divinità del Caso.
La visione di Szymborska, così essenziale, è completamente coincidente con il suo stile. Possiamo anzi dire che lo stile apparentemente naturale (“Non avermene, lingua, se prendo in prestito / parole patetiche, e poi fatico per farle sembrare leggere.”) di Szymborska concretizzi in diretta la sua visione del mondo tra “incanto e disperazione”. Uno dei rari testi apertamente “disperati” di Szymborska, CAMPO DI FAME PRESSO JASLO, incomincia con: “Scrivilo. Scrivilo” e ricorda In luogo di prefazione a Requiem, la poesia scritta da Achmatova sulle madri in fila dietro i cancelli delle carceri di Leningrado: “Ma questo lei può descriverlo? / E io dissi: / Posso / Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto”. La poesia, in certi casi, ha il dovere di testimoniare.
Più avanti nel tempo, Szymborska identificherà nitidamente la propria caratteristica virtù in una variante dell’incanto: lo stupore: “Potevo essere me stessa – ma senza stupore, / e ciò vorrebbe dire / qualcuno di totalmente diverso”. Dello stupore parlerà anche durante il discorso tenuto in occasione del conferimento del premio Nobel: “Il nostro stupore esiste di per se stesso e non deriva da paragoni con alcunché”. Questo stupore – e l’incanto che l’ha preceduto – non è certo una puerile fuga dal reale, ma – al contrario – il dono dello sguardo di una fanciullina pascoliana, pur nel nitore di pensiero e nello scetticismo di una poetessa ultracontemporanea come lei (“il poeta odierno è scettico e diffidente anche – e forse soprattutto – nei confronti di se stesso”).
Nei testi di Szymborska splende in silenzio, infatti, l’unità di tutto il creato e l’importanza data all’uomo come a una qualunque tra tutte le altre forme di esistenza. La poesia di Szymborska non è antropocentrica, bensì “universale”, nel senso più potente e comprensivo. Questo perché anche ciò che è umano ci rimane comunque sconosciuto: “Conosciamo noi stessi solo fin dove / siamo stati messi alla prova. / Ve lo dico / dal mio cuore sconosciuto” e ancora: “Solo ciò che è umano può essere davvero straniero. / Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento”.
Il mondo è il luogo dove noi gettiamo la nostra ombra qualunque – e la nostra ombra è il rovescio buffonesco della disperazione e della nobiltà (“la mia ombra è come un buffone dietro la regina”). Alcuni fortunati possono adoperare la scrittura, ovvero la costruzione di un mondo del quale lo scrivente ha in mano le sorti (“la vendetta (su dio) d’una mano mortale”), ben consapevole che gli esseri umani non si piegano al nostro volere come i personaggi fatti di parole, come la cerva che si abbevera all’acqua scritta di un bosco scritto. L’arte del mondo nasce semplicemente dal mistero del mondo, dal suo rimanerci inconoscibile: un mondo chiaro e svelato escluderebbe l’inquietudine e le domande che motivano l’arte. Fra esse, la poesia.
“INSEGNO il silenzio / in tutte le lingue” fa tornare alla mente l’affermazione di Tranströmer della poesia come traduzione di una lingua invisibile. Forse tutta la poesia traduce la voce del “silenzio”, la voce primigenia del mondo. A questo immaginiamo faccia riferimento Szymborska in PICCOLI ANNUNCI.
La sua universalità accade infatti soprattutto perché, come scrive lei stessa (e, come accade a quei rari poeti, la sua vita è coerente con quel che scrive): “Anche una vista affilata fino all’onniveggenza / a nulla ti servirà senza il senso del partecipare”, visto che “chi guarda dall’alto / sbaglia più facilmente”. Ogni forma esistente gode dunque della propria forma di conoscenza – e anche il non conoscere e non interrogarsi della pietra, è uno stare cosciente dentro una sapienza minerale. Dentro una capienza minerale.
E il minerale non muove a compassione, il minerale non sente. Dopo un cammino a lungo ondivago tra ironia e atarassia, Szymborska inclina sempre più decisamente verso lo stare semplice e senza nome delle cose del mondo. Quella di Szymborska è certamente una poesia “con storia”, per rifarci alla nota suddivisione cvetaeviana tra poeti con storia e poeti senza storia: Szymborska innalza fin da subito il canto della provvisorietà, tutta la sua poesia è un inno alla provvisorietà, la poetessa sostiene esistenzialmente ed elogia poeticamente il fondamento cardinale dell’umano: la provvisorietà e l’incertezza, sopporta al posto nostro e insieme a noi la mutevolezza del reale e, insieme, la sua inimitabile singolarità, a volte intesa come prigionia non voluta, non scelta – dentro una determinata, singola, immutabile forma – quando sembra desiderare una declinazione collettiva e comunitaria dell’io individuale. Ma da quell’io singolare viene erogato amore verso altre singolarità: “preferisco me che vuol bene alla gente / a me che ama l’umanità”, sebbene l’anima (che diremmo la facoltà di comprensione amorosa) non sia un’acquisizione assunta una volta per tutte, ma accada anzi quando gioia e tristezza sono in noi unite, quando integriamo in noi gli opposti fondamenti sentimentali, quando siamo incerti e curiosi. Raramente, con estrema prudenza e con pudore estremo, Szymborska si pronuncia sull’amore erotico: in ACCANTO A UN BICCHIERE DI VINO, seppur sempre schernendosi, dice lo sguardo dell’innamorato creare per intero l’essere amato, la poetessa stessa: immaginarla di nuovo, farla rinascere dal proprio desiderio – come in Sposa e sposo giacciono nascosti per tre giorni di Ted Hughes il corpo dell’amata viene riforgiato dalle mani amorose dell’amante. Quella messa in scena da Szymborska è però la denuncia di una ricreazione proiettiva, incerta della verità, forse francamente lontana dalla realtà e concretezza del proprio oggetto d’amore.
Perché la vita (e, con lei, la poesia) è intesa come un lungo (si spera!) cammino di apprendimento che Szymborska cammina sotto gli occhi di tutti. Senza nessuna enfasi. Raramente vittima dell’imprudenza del pathos. Con i piedi per terra. Di apparenza concreta. Ma: senza distinzione fra terra e cielo. Lei dimostra che vivere non è vano, lei accumula esperienza, impara. E questa è una sua dote scoperta e umanissima, che ce la rende vicina come noi stessi.
Quella di Szymborska diventerà, con il tempo, soprattutto poesia del “lasciar andare”. Come in Antonella Anedda, quando parla del nostro amore proiettivo nei confronti del nulla dei morti: “Chi se ne è andato non desidera tornare. / Pensiamo che si strugga per il mondo / prestandogli la nostra nostalgia”. Ecco. Lasciare finalmente andare. Anche i morti. Osservare con occhi asciutti la loro morte e la vita intera. Di più, osservare con un sorriso lieve, divertito, quest’avventura umana tanto precaria, nella quale noi siamo, come tutti, comparse. Nella quale noi siamo, nostro malgrado, comparsi.
Questo afferrare i fatti, questo avere a che fare con i fatti, con la brutale faccia del reale, con la commovente faccia del reale, dove la commozione e la bellezza sono date proprio dalla provvisorietà (“la mia mortalità dovrebbe commuoverti”, scrive in CONVERSAZIONE CON UNA PIETRA) è la meta ultima dello stare in terra. Quando non abbiamo più bisogno di maschere e infingimenti per sostenere la vita, possiamo osare una qualche felicità. Accettare le cose come sono, anche l’umano, ovvero “il Bello / con dentro budella sgraziate”. Questa la grande lezione di Szymborska, questo il motivo del suo essere tanto amata: Szymborska ci insegna a trovare belli la provvisorietà, il dubbio, la perdita, insegna a scrivere versi come “è un’ombra – troppo mia perché mi senta alla meta”. Senza lagno romantico. Con leggerezza. Fedeli al dio dello humour: in FILM – ANNI SESSANTA viene descritto l’incessante lavorio umano nonostante la (o, più probabilmente, proprio a causa della) consapevolezza della morte e di una solitudine inguaribile, e Szymborska ci spiega con rara commozione cosa sia lo humour: “In lui c’è un’orrenda oscurità e in essa / un bimbo. // Dio dello humour, fa’ di lui qualcosa alla svelta.”
Come ha agito profondamente bene questo dio su Szymborska, che sa chiudere la propria intera opera poetica con i due punti: – ovvero con una domanda definitivamente senza risposta.

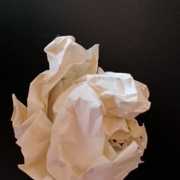


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!