Deposizione (26.8.06, Roberto Corradino)
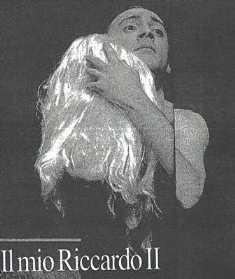
oratorio di Maria Grazia Calandrone interpretato da
Roberto Corradino su partitura originale del maestro
Alfredo Cornacchia
prima assoluta in gravina di Ginosa il 26.8.06 per il festival “Le grandi narrazioni”
DEPOSIZIONE ovvero RICCARDO II NESSUNO
Benediciamo e non vogliamo essere
che un solare contrasto
uno stare indifesi
nel viluppo cromatico all’inizio
dell’inerzia temporalesca
uccelli mattutini sul cemento
del fiume in secca
in stato di completa nullità
come catrame e gemme.
Chiedi alle tende quale piccolo oggetto s’inchini per un fenomeno di rifrazione al passaggio di un martire – a me
che sono stato cosa della natura la natura confida un segreto: io
posso farmi femmina e sembrare
di cedere, dare piuttosto con le mie mani quanto la vita nella sua interezza raduni
nel pozzo d’ombra azzurra di una corona.
Le stelle sono fatti luminosi
sostengono le case
in latitudini abnormi – chiariscono
i nostri passi alati e sereni quando entriamo di sera nelle sale vuote. Da svegli
ricordiamo come furono ciecamente felici i nostri nomi
per la gloria che ci faceva salire come inverni nel moto meccanico della neve, ricordiamo
la fatica lentissima degli insetti, quel vasto nascere
all’alba nella parte assegnata di mondo mentre noi eravamo già dati alla luce.
Il portamento volge verso il sole: sono un idolo femmina
di terraferma
manufatto senza meraviglia
con le mani con gli aghi con i bisturi
e le palette da incisore – dilaga
l’orfanità divina come fiele all’altezza di una madre che lavora nel petto fango e respiro
della generazione omicida.
Io smisuratamente sono qui e non sono
corpo amputato della gloria liscio come il sasso con nudità che inizia
dallo scheletro. L’osso
è la povertà che portiamo nel mondo dalla nascita
la parte assiale di un orizzonte finito. Migriamo eretti dai laghi
di cera dell’infanzia e mentre il corpo si vanifica e cede sviluppiamo
nel sempreverde
guano dei piedi la tendenza al ritorno. Come aironi
azzurri e adolescenti con il canto a memoria nei timpani teniamo
la rotta, resistiamo
ai richiami di folaghe insonni che minacciano il viaggio
dal fondo di noi – da abitanti
di cieli tolemaici imitiamo le ruote e le picchiate
per prepararci al vento di maestrale fino a che non sappiamo
se davvero cadiamo e perché queste ali ci abbandonino e dove.
Alzo la mano come uno stormo disperso per coprire la testa
dove cominciano ad affiorare cose
con lo sguardo degli undici apostoli: i miei occhi
gonfi di mondo come sacchi di spine e monete e nei canali
lacrimali che sono golfi
di vele arse i soprassalti di uno sguardo acquatico e infantile: nel traditore
splende il mutismo dell’infanzia caparbia delle campagne mentre io sono un corpo
già infetto nella fucina di materie molli della terra
sono la porta a vento dell’oriente
che ficca l’erba vergine dei suoi pascoli nella bocca dei morti e disperde
insieme ai ladri il ruscello che fiocca di pena degli innocenti.
Dove inizia la liturgia del corpo
l’ala si piega
alla sua parte di dolore, smette
di ragionare – la vittima
attraversa la terra
china sul suo presentimento
e a ogni passo si disfa
lascia le mani
sulla bocca dell’altro se stesso che ancora grida nella sala del trono.
Lo scioglilingua delle nuvole al vento – e il vento
passa, dinoccolato carrettiere
per le contrade e fischietta
fino alla fine del mare, quel compulsivo raccolto di reti
tirate a sangue con l’intrico dei corpi senza urlo sul bordo
striato dalle vampe che si inginocchia da ogni lato su un fiore di sangue.
A primavera le operaie trasportano le larve: penitenza dei corpi senza ossa che vengono traslati
a occhi chiusi, potenze
morte nelle quali è il futuro di ogni specie, le condizioni sentimentali nelle quali versano
i non nati e i morti come interferenza.
Alcuni cercano tra le montagne strie di voli dispersi
come lo stormo delle leggi, qualsiasi cosa sincera
corpi spogliati che offriamo in ostaggio per rimanere vivi. Siamo
perle, orbite tolte dal fondo del mare
e cerchiate di scavi e di tracce di sangue nel volto infero della renella, siamo pianeti disseccati e il pianto degli uomini che non li tocca.
Il vuoto delle lacrime sta più in basso del volto e risucchia
il deserto del corpo, i margini sbiancati all’acetone e la chiostra
dei denti che serrava coltelli medievali e ciliegie
ha la cupezza dell’ala sfilacciata che non tenta la residenza d’aria.
Tremarella di alberi al vento. Un intero
bosco trema nel corpo
di chi smette i suoi panni, dimenticato
subito come neve d’oro. Arroganza e delizia del suo essere
vuoto – cuore brado di bestia, cosa
che non entra nel petto di Dio.
La cremazione di Cesare – la bordura la rima di cera
del corpo di Cesare l’astuto
ora vale la calma immateriale delle calamite e degli attrezzi
da cucina. Splende solo
l’insenatura di bontà che ci è messa
gratuitamente nell’anima come l’ascia
del tardo sole sul palco botanico. Questo
il risultato, la caduta sospesa per quel filo di luce nelle sale
nel modo in cui si mette
il corpo nel letto come un mattone.
Studia l’angolazione della luce, il moto ponderoso delle gocce come una macchina nera sfondata
di traverso dal sole, copia lo sfascio idraulico del corpo
dismesso e misura nel mezzo
la caduta cartesiana dalle vette
del cuore che torna
a quando la terra fioriva
di me che ero cosa non fatta
di stagioni e con gli altri
sulla flotta ammiraglia della montagna
ero una sera
profumata di latte e gelsomino
che si capisce dopo la scomparsa.
Atto IV – Deposizione, libretto
Corriere del Mezzogiorno, 25.8.06 




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!