Caproni Giorgio, Roma la città del disamore (il manifesto, 24.1.13)
Giorgio Caproni – Roma la città del disamore, a cura di Elisa Donzelli e Biancamaria Frabotta (De Luca Editori d’Arte, 2012)
I poeti fanno della libertà il proprio mestiere, raggiungono una realtà più vera del vero appesi alla luce medianica delle parole: e sarò con Mafai sul Ponte Garibaldi, un ponte com’è nel nostro cuore, più vivo e vero che “nella realtà”: qualcosa un tempo li ha portati di peso via dal mondo, ma in cambio ha dato loro il dono di vedere un mondo alla seconda potenza, una specie di radiazione luminosa o una sua area oscura che abbaglia più dell’evidenza evidente e solida della realtà. Così, la caproniana noia di sé non coincide con una cupa e cruda pulsione di morte, bensì con una lenta destrutturazione della propria persona psicologica, con un lungo esercizio di disinteresse nei propri confronti, che finisce per significare rinnovamento della voce, ormai di altri se non corale (penso in particolare allo splendido Il seme del piangere). E questo tanto meglio può avvenire in una – o meglio: a partire da una – città come Roma, dove i ponti, sul pachiderma fluviale giallo di urine, sono diffusi come archi voltaici tra vita e morte, come sonde e lingue di contatto lanciate tra il regno dei vivi e quello dei non-vivi: una quasi perfetta metafora della lingua poetica, se Caproni descriverà se stesso come uomo Solo in una stanza vuota, / a parlare. Ai morti – dove morti rima con torti.
La voce corale di Roma e dei morti di Roma suona due volte nei poeti, perché contiene il canto melancholico della stratificazione delle rovine, che sono una cara compagnia e insieme un monito sul nostro presente – o addirittura declinano al futuro, sono macerie che crollano al futuro, fin che nel cuore aperto e chiaro del poeta s’insinua la visione di una Roma quale dismisurata città di bottegai: ora Caproni vede la città che lo ospita come un conglomerato cementizio e marmoreo, sfacciato e insidioso nella sua vastità – mentre Genova gli splende nella memoria tutta fatta di luce scoscesa. Ma Genova è soprattutto lontana. Per Caproni, suo abitatore iniziale, la città-Roma è sinonimo vivo di libertà come l’albatro di Melville, ma, vivendo in essa, il poeta diventa l’albatro baudelairiano che non sa camminare sulla terra.
Forse perché il rovescio della libertà è l’indifferenza: l’attenzione di Simone Weil, che consiste nel mantenere ai margini del proprio pensiero le diverse conoscenze acquisite, è un fenomeno di concentrazione filosofica che una metropoli non può concedere. Ascoltiamo Melville difronte all’albatro, magnifico esponente di una grazia originaria: l’essere bianco era tanto bianco, le sue ali tanto immense, e in quelle acque del perpetuo esilio io avevo perduto le meschine memorie di tradizioni e di città, che ci distraggono. La metropoli invece è “distratta” – e lo sono la tradizione e la storia. Ma un poeta è un’antenna che cammina e una città così grande e profonda come Roma, così arcaica e traboccante di pulsione umana, non poteva che spingere ai suoi margini psichici chi con lei non avesse una consuetudine già infantile o chi, come Pasolini, non avesse eletto come propria patria d’esilio le sue borgate e i suoi ragazzi randagi, per sentirsi egli stesso sempre straniero e randagio: Caproni non amava la condizione dell’esilio come Melville e Pasolini, Caproni era tutto fatto di nostalgia.
Oltre alle caratteristiche dell’uomo individuale Giorgio Caproni, occorre però sottolineare quanto l’ondata nera e anomala del fascismo malignamente dilagasse e sommergesse la metropoli-Roma di Caproni. Il fascismo è contrario all’attenzione, è un disbrigo violento e sommario di pratiche vitali – e le sue conseguenze sono la guerra e una deportazione non più simbolica della intera cosa umana, che Caproni scoprì in diretta quando il settimanale “Il Politecnico” lo incaricò di indagare la vita nelle borgate romane nate dopo lo sventramento fascista. Questa opportunità giornalistica rivelerà a Caproni una sgolata infanzia romana, quei bambini gettati senza padre né madre per le strade a contendersi un pallone, la disperata normalità di un gioco in uno sconfinato spazio di esilio. Le descrizioni che Caproni fa di Pietralata e soprattutto di Tiburtino III sono da inferno dantesco: Roma della guerra e del dopoguerra è ormai l’esilio per Caproni, che pone definitivamente la sua persona poetica dalla parte degli spatriati, sebbene goda di amicizie letterarie romane che immaginiamo splendide. Sopra tutti cammina Pasolini, con il quale Caproni macinava chilometri, parlando poco ma osservando molto, in un paesaggio ancora a pezzi per via della guerra. E se l’uomo è alla ricerca di un centro morale, prima ancora che estetico, come scrive ottimamente Biancamaria Frabotta nella sua nota, possiamo immaginare con commozione quei due uomini immensi, il nerboruto e il sottile, passare in piedi fra le macerie, osservarle per assumerle, così diversamente, nelle proprie parole e, con la forza centripeta delle proprie parole, collaborare alla riedificazione di quel paesaggio in frantumi.
Possiamo dire che la poesia si chinava a raccogliere quanto il fascismo aveva gettato via. Nel doloroso frangente, si trattava di uomini.
Per comprendere ancora più profondamente il catastrofico e ironico disamore che corse tra Roma e Caproni, ci facciamo aiutare ancora da Melville e da Frénaud (autore che Caproni conobbe tanto da tradurlo). Se Melville scrive: Quantunque in molti dei suoi aspetti questo mondo visibile appaia fatto nell’amore, le sfere invisibili vennero fatte nella paura, Caproni dovette avvertire in Roma questo sottinteso umbratile, il brivido invisibile generato da uno strato di umidità sepolta e puntuta di ossa, il rovescio stregato del sole in rogo, l’incantamento aguzzo di ognuna delle pietre dette sante. Fascino e paura dei colonnati e della pietra – e ancora una volta, oltre l’umana sopportazione: amore, soprattutto per i cari completamente morti che percorrono come apparizioni la città. La strega di Roma di Frénaud racconta esplicitamente una vista di Roma femmina e affatturata – e mette in scena, nel viscere esposto di lei, un sé autoriale moderno, ambivalente e fratto. Roma è il risultato, sotto gli occhi di tutti, della storia dell’uomo, la chiave della cui infelicità è una desolata mancanza d’amore. Roma è per Frénaud il luogo dove si palesano insieme il disamore che si subisce, la frattura di sé nei frammenti molteplici di un vivo e la storia degli uomini. A Roma, in questa città che è sempre esistita, Caproni dev’essersi sentito difronte all’assenza di Paradiso. Possiamo dunque immaginare che il poeta patisse fieramente lo spettacolo desertico del disamore nelle ere umane, che si concretizzava proprio sotto il suo sguardo, nella feroce espulsione dei lavoratori verso la discarica delle borgate, soggetti alla spinta centrifuga della megalomania mussoliniana. Caproni ripaga una tale evidenza con disamore eguale. Ma un animo simile al suo non regge a lungo, privato delle sue lanterne magiche – e dunque ecco che la città “eterna”, con le sue evocazioni ultramortali, la grande curvatura dell’universo / ripresa in gloria dalla circonferenza del Colosseo (Frénaud), si muta in una forma di prigionia che permette l’amore a distanza, l’evocazione, che permette di amittere la rem e di operare l’alchimia poetica con Livorno e con Genova quali potentissimi luoghi del rimpianto. Tutto questo emerge con estrema chiarezza dalle pagine del catalogo della mostra: ideata, curata e commentata con grandi competenza e passione da Elisa Donzelli e che – come scrive lo stesso Caproni a proposito di altre monografie edite da De Luca – mostra un’idea vivente del poeta, ne rivela l’acume e la debolezza, l’ironica ferocia e la malinconia quasi infantile. Il disincanto, insomma, quel disamore che non ci si aspetta quando si è ancora pieni di stupore.

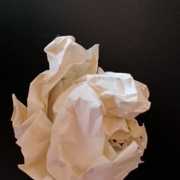


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!