SHAKESPEARE, William (Poesia n. 278, 1.13)
WILLIAM SHAKESPEARE
Di me si sa poco perché poco importa sapere di me. Quel che avevo da fare sulla terra lo hanno fatto le mie parole.
Gli scarni eventi sono che nacqui Gulielmus nell’aprile del 1564 e cominciai dal teatro, del quale pure calcai le scene – ma, soprattutto, fui capace di continuare a scrivere doppiando le boe della censura elisabettiana: senza parere, giocavo col giocattolo della religione e rimpolpavo il corpo dello stato umano intorno alla colonna, alla spina dorsale della filosofia: ero atterrito dall’errare degli uomini, dagli abbagli del giudizio che conseguono a fretta o all’incertezza – ma il mio uso talmente disinvolto, esorbitante, allegro e intelligente delle parole nel trattare di temi così frusti, compromettenti e metaumani, mi valse uno dei rari successi in vita, sebbene fossi spesso insoluto, nel trarre in scena le conclusioni al dramma tragicomico dell’esistenza. O forse, piacqui proprio per questa mimesi ferina con l’esistenza stessa, che mai risponde: io sapevo cosa tocca l’animale umano – e anche voi – e io stesso – continuiamo a ridere e piangere, dentro il sollievo delle mie parole. Una antica catarsi. Solo alla fine della mia scrittura venne lo scioglimento nel perdono, mentre piegavo sempre più il blank verse al desiderio d’aria del mio stesso respiro, che forse era un anello dell’evoluzione umana, se alcune espressioni dei miei eroi di carta sono entrate a far parte dell’inglese moderno e dei modi di dire dell’Occidente e le persone che si formarono nella mia mente sono ancora un patrimonio dell’umanità, figure mitologiche pari a Edipo, a Cassandra. Il mio pallido Amleto non sfigura accanto ai nerboruti eroi greci. È soltanto più inquieto, più moderno e diviso. Certo. Su di lui devo dirvi che Anne, mia moglie, e io rimanemmo orfani del nostro Hamnet quando aveva 11 anni. Scrissi di Amleto dopo questa perdita. Così, volevo dirvelo. Per “confessarvi che ho vissuto”. È stato probabilmente a causa di questo mio vivere fortissimo, che ho inserito la mia opera nella catena del progresso. Non occorre dunque far polvere con la mia vita e tanto meno con le mie ossa: come tutti gli autori, sono le mie parole e sono Amleto, sono Giulietta e sono Romeo. La natura, esuberante, ingiusta e volitiva quando cumula doni su una persona, mi aveva messo a parte dei segreti del mondo. Della mia vita “reale” occorre infatti che sappiate ancora che la mia compagnia “The Lord Chamberlain’s Man” venne assunta dal re. Io scrivevo, mi mettevo in scena e amministravo i beni della compagnia. Così, divenni un uomo ricco e persino un suocero ricco. Costruimmo addirittura un teatro, un Globe vero di legno vero. Ma, nello stesso tempo, tutto il mio petto, messo in mezzo alle cose come un legno che tiene la tempesta, risuonava di eterno come il volto immaginario di Omero – un volto che noi tutti formiamo a partire dalle sue parole e poi riconosciamo come riconosciamo una divinità necessaria – o la solitudine di un parente lontano, troppo alto per noi: avevo la coscienza costante dei paradigmi della natura umana e dei suoi fondamenti. Allungavo la mano sotto il fango dell’uomo per toccare la sua radice di luce. La fondamenta. Ma non ero imperfetto, ero esattissimo – e fui nuovo per questo: maneggiavo le psicologie umane come un giocoliere, soffiavo un fiato superumano nella vita artificiale delle parole perché amavo la vita incommensurabilmente, mi sono sempre mosso per natura dalla parte dei vivi. Pensate: alcuni scrivono che sia impossibile che un uomo solo abbia prodotto tanta bellezza e tante intelligenze e che dunque io sarei un coro di intellettuali rinascimentali. Ma che importa chi io sia? Essere o no è un rovello superato dal tempo, era un effetto del sorriso inquieto della giovinezza. Noi siamo tutti in lotta col tempo per amore di amore, per amore di un incantamento spesso disincarnato. L’amore è una occupazione solitaria, come scriverà una donna tanti secoli più tardi – e nell’amato riconosciamo tutti i nostri morti, che si sono annidati nei suoi occhi e da quegli occhi irradiano sopra di noi il tepore di una tenerezza perduta. Adesso importa che l’amore che mi fiottava incontenibile dal petto e si è depositato nelle mie parole, formuli una continua fiducia amorosa, che la catena della compassione non si fermi, importa che l’amore si riproduca. O dov’è uomo sì pazzo da voler esser tomba / Dell’amor di sé: io non parlavo solo della riproduzione della carne! L’amore stesso in fatti deve propagarsi: nei fatti e nei discorsi. Il protagonista dei miei versi è amore, una mischia di sessi e carità: poco importa che la liturgia amorosa che ho celebrato con i sonetti fosse destinata a un bell’amico o a una donna dal vero sembiante: importa il tributo, testimoniare di essere stati arsi e sciolti come cera su un altare terrestre, importa manifestare a nome di tutti che la terra non è una storta briciola prigioniera nella rete del Tempo – la terra infatti è vedente – importa mostrare di avere avuto un cuore combustibile, pure in un corpo fatto d’acqua e terra, testimoniare che, nel fatto di fango che pure siamo, sta il bagliore di una memoria, lo stampo di una eternità che ci ha informati di sé una volta – e che fu luce e lotta nel grumo di fanghiglia che io fui, prima di diventare puro pensiero e raggiungerti, amore, chiunque tu sia.

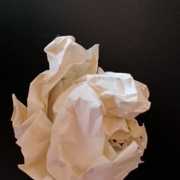


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!