Magrelli Valerio, Il sangue amaro (Poesia, 4.14)
Farsi il sangue amaro vuol dire arrabbiarsi o, più precisamente, arrovellarsi all’eccesso o senza costrutto su problemi di difficile soluzione, assoggettarsi, in maniera convulsa (segnaliamo, fin d’ora, questa forma emotiva quale veicolo della bellezza) e inefficace, a furie di natura atrabiliare. Nel parlato, l’espressione viene comunemente associata a un affettuoso invito: “eddài, non farti il sangue amaro!”. Colui che invita, invita dunque a un sollievo, al conforto del “non ci pensare”, alla leggerezza del cuore che induca infine il melancholico a una beata dimenticanza. Quale poeta è amico di se stesso? Così, Magrelli semplicemente descrive Magrelli, scuotendo il capo con rassegnazione, essendo egli, come spesso i poeti, tenutario e spettatore del teatro di un io contingente, quanto meno biologico e biografico. “Tutti i poeti sono ebrei”, decideva Marina Cvetaeva nel poema della fine, lanciando la freccia della sua profezia dall’inizio del secolo scorso, per indicare, a quell’altezza storica, le qualità di diaspora e d’esilio, la natura apolide consustanziale al versificatore. Il sangue amaro di Magrelli fa eco alla sentenza cvetaeviana dalla foce di un Novecento che ha issato sulla terra degli uomini la bandiera di un io non più corale, ma fratto nella sostanza e graffettato in extremis, da un’intelligenza prensile e psico-analitica, che tiene insieme tutte le nature nel denominatore della coscienza, tanto dis-incantata quanto la voce di Cveateva era un fluido costante, che si abbeverava all’incantamento di sé e del proprio ahimé non troppo dolce avvenire.
La decrittazione autoriale del Sangue Amaro si trova però nel primo testo della sezione omonima, posta a fine libro, quasi una nota dispiegata al vento dell’ironia prima delle note. Ovvero: ci viene detto di cosa si tratta quando abbiamo ormai attraversato l’intero libro, ora che siamo stati già sbalzati tra i singhiozzi del pianto e del riso, tra le dolcezze e le invettive che fanno un uomo. A un passo dalla chiusa, Magrelli si scaglia contro l’IO IO – IO IO – IO IO: giambo letale. Egli ha infatti descritto per l’intero volume bradi animali umani, che circolano continuamente tra dentro e fuori, alla soglia di una separazione necessaria che viene a volte violata, o nelle cui segrete rimanere sigillati come da finestroni teutonici troppo perfettamente gravi e chiusi. Ora nostri custodi sono i cardini anzi che gli angeli.
La serie La lettura è crudele dice proprio la vertigine di un io che si sporge su un altro io, intento a un rito di separazione, “se è vero che il linguaggio / ha innanzitutto lo scopo di nascondere”: osservando il corpo di un leggente, si prova lo stesso sperdimento che si prova davanti a chi ci esclude sognando. Abbandonati sul ciglio di un abisso onirico. Chi sono i nostri amati quando noi non ci siamo? L’osservazione della lettrice amata porta sulla scena della coscienza magrelliana il desiderio mai dimenticato di possedere l’altro, perdendosi nel suo lungo segreto – desiderio ovunque contraddetto dalla paura dello smarrimento, poiché, diventando adulti, ci siamo persuasi che il paradiso originario contenga in sé il morso mortale della perdita dell’io, al quale siamo abbarbicati come le scimmie all’albero di un falso Eden. Così, già stretti al tavolo delle certezze, ci troviamo decisi a pasteggiare, più o meno dignitosamente, con un cibo che manca.
Ma come caldamente sopravvivere? Ecco, ad esempio: a tanto sostanziosa densità emotiva, Magrelli alterna lo scudo della propria leggerezza, ironica e tenebrosa insieme, declinata in versi come “Qui, tutti noi aspettiamo / sulle rive del Nihil”, dove rappresenta i funerali laici non-celebrati nel Tempietto Egizio di Roma, con il medesimo humor e la medesima topografia del disincanto dello scrittore Jep de La grande bellezza, abulico e sorridente: “siamo tutti sull’orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che farci compagnia, prenderci un po’ in giro”. Meteorologico o meteoropatico autore, scientifico o piuttosto infastidito, umorale. Sostanzialmente pieno di fiducia. Ragazzo, infatti, Magrelli già scriveva “Scrivere come se questo / fosse opera di traduzione”, anticipando la dichiarazione di fiducia di Tranströmer nel farsi tradurre, se ciascuna delle nostre parole è a sua volta trascrizione di un linguaggio invisibile, di una lingua bianca celata dietro il suono del mondo, che la musica e la musica delle parole riescono talvolta a cogliere. Quale informazione cercava veramente il giovane Magrelli dal maestro Barthes, se infine esce dalla casa di lui con la sola notizia che la musica tolga dal silenzio il suono sommerso del mondo, lasci apparire l’ombra della casa perduta dietro l’ombra del mondo, ci faccia capaci di sopportare il singhiozzo del mondo, la visione vera, anche nella forma ultraprosaica di giovani privati della dignità, della libertà e della pavesiana stanchezza del lavoro? Questa coscienza di una casa battuta dai venti di un altrove, ci permette di sopravvivere anche all’intollerabile immaginazione delle torce umane della Thyssen o alla visione delle umane schegge di fuoco dell’11 settembre, vittime per mano umana, e anche alle vittime di una natura che riprende il dominio di sé, trema, si rende nuovamente inabitabile, inaudita e convulsa nel suo sciame sismico, che ci lascia scoperti come bestie in esilio: “animali marini che vivono sulla terra e che vorrebbero volare”, per estendere al genere umano la bella definizione che Carl Sandburg dà dei poeti. E Magrelli, che vede la lapide sotto un eccellente fritto misto, assume la sua quota di sangue amaro.
Il sacrificio è infatti l’incarnazione nel nostro sangue. Farsi uomo è darsi in pasto, darsi in sacrificio. Ci mantiene vivi il conforto del piccolo branco che si protegge vicendevolmente, perché ha stipulato un antico patto di bene, e la scrittura fa di questa carne un codice dolce e avvelenato, raramente divino, spesso d’occasione, impastato alla casualità crudele della vicenda umana, anche alla caduta irreversibile e senza resurrezione di un ragazzo investito, amputato dell’amputazione delle sue altre figure potenziali, se crescere significa scegliere progressivamente una vita sola fra quelle possibili e, se tutto va bene, scoprirsi un giorno contenti perché si hanno i denti, un bagno nel quale lavarli e una figlia, lì dietro il muro, che canta. Ma forse anche dalla zona franca del bagno di quel ragazzo si sarebbe levato il rumore dell’asciugacapelli, che, per lui come per Magrelli, avrebbe contenuto il frastuono di un lavacro di sangue capace di sconvolgere l’ignaro dall’umida chioma.
Da Domani mattina mi farò una doccia, contenuto in Ora serrata retinae, splendido esordio liminare tra sonno e veglia, i luoghi delle soste provvisorie sono per Magrelli zone d’interesse, luoghi sospesi dove siamo più vuoti e le interferenze del mondo arrivano amplificate, fanno eco più grande al ronzio della nostra coscienza, musica umana offerta all’inframondo nella forma di un piccolo mucchio di flauti spezzati. Ascolteremo l’incessante brusio del mondo interno-esterno fino a che, senza vista e parola, cadremo in quella che non sarebbe la caduta rilkiana “di quando cosa ch’è felice”, ma la mortale caduta senza visione citata nei Frammenti di un discorso amoroso di Barthes: “ La morte è essenzialmente questo: tutto ciò che è stato visto, sarà stato visto per niente.” (François Wahl). Ma noi lasciamo tracce. Sebbene gettati nella separazione e nel frammento, rinasciamo laboriosamente abili a sopportare la separazione e il frammento, l’ormai assorbita visione dell’altro che si rintana il quel suo proprio abisso, con alibi abusati e poco credibili quali dormire e leggere, lasciando il corpo come un vestito vuoto sulla sedia, la casa dolce del suo corpo trasformata in una località provvisoriamente disabitata. Così visti e obiettivi, possiamo arrivare nietzschianamente a osservarci anche dal punto di vista del nemico (senza però perdonarlo: l’inimicizia va tenuta a distanza) e il distacco dal nostro consueto e indulgente osservarci, serve a una crudeltà dolce da macelleria dell’anima, che finisce per identificarci nella nostra debolezza. Ma lasciamo tracce. Anche biologiche: nel passaggio dallo slancio quasi infantile, energico e pieno di fiducia di certi versi all’incupimento di altri, Magrelli somiglia al padre scritto in Geologia di un padre, per il quale ripubblica qui Occhio, ché il Pellerossa, dedicato alla sua (di chi?) corona ippocratica – altrimenti detta calvizie: anche in essi l’autore osserva il proprio lento calarsi nel calco biologico del genitore, il proprio arrendersi al destino genetico e di specie umana, alla “ferita non rimarginabile, ossia la mia professione”, nata dallo spettacolo di un’antica umiliazione paterna, e infine al suo convulso sottostare alla convulsa bellezza del mondo, restituita a ondate che sono frutto di cesello e arguzia e talvolta si placano sulla riva di una pacata maschera adulta. Magrelli innalza di continuo il porticato di un tempio, anch’esso egizio, sull’architrave del padre. Non depone una lapide, forma un vivo, tanto amato da potere davvero finalmente morire.
In tutto il lavoro di Magrelli c’è l’arredo di questo e tanto altro corpo, che afferma la sua provvisoria esistenza ed è sondato come fosse davvero trasparente, mentre porta una vera gratitudine all’astuccio che ci preserva dal suo intimo scenario idraulico, ematico, crudo, che permette anche il sesso e la manualità nemmeno troppo lieve del gesto poetico. Scrivere è però quell’ambiguo seminare i caratteri (tipografici) di una distanza, quel dolce e pericoloso sostituire al corpo carnale un corpo di segni, dietro il quale traluce la materia carnale del poeta, la materia fluviale che nasce e rinasce dal disgelo del cuore, ma come durante l’esumazione dei corpi sembra appaia il barlume dell’immagine viva, che immediatamente si dissolve dentro il tocco dell’aria. La pena analitica che Magrelli ha sempre provato per il proprio corpo, dalla testa tagliata del femore che manda odore di bistecca cruda nel condominio di carne alla testa del proprio corpo intero, che sporge come una pianta o un grande frutto dalla terra del letto dove è radicato in Ora serrata retinae, si movimenta ora nel gusto per la vita necessaria: dal bagno nel fiume, caldo come una vena organica, all’opposto scricchiolare della Nevà al vento, che la muove come un ghiacciaio in frantumi e decompone l’ordine razionale dei soldati. Ancora: le viscere fluviali della casa, sì, ricordano i visceri umani, il freddo seminterrato di vene, dove scivola un sangue che la pellicola dell’epidermide tiene separato, confezionato nel suo fodero di odori e sapori, sì, ma hanno anche derive improvvise e altrettanti improvvisi tradimenti del muto stato delle cose: il vento, il terremoto, questa testa di femore fuori dal corpo e le tracimazioni, tutte le cose che sfuggono alla logica ordinaria, sono forze fuori controllo, che sottolineano la nostra fibra umana naturale. L’improvviso disordine del corpo e della natura ci ride in faccia, neutrale, imponendo su di noi la sua potenza di disarginare, disarcionarci dalla cavalcatura della terra, sulla quale ci siamo issati a forza di intelligenza e logica. “La società ha addirittura creato un gigantesco strumento mentale che cattura tutte le espressioni umane nell’inganno e nella falsificazione: si tratta della logica, arma con cui si impedisce che ragionamenti, discorsi, pensieri si sottraggano alla mascherata universale.”: così scrive Giulio Ferroni, riferendosi al saggio di Pirandello su L’umorismo come scomposizione della forma, ovvero sentimento del contrario.
E questo sangue amaro che, come un pesce di fiume, si rovescia nel trascinio dell’acqua e rivela il riflesso argenteo della sua pancia e della sua risata, è la cifra che Magrelli affina, dalle origini, per abitare il mondo, col proprio corpo e con il corpo della propria opera. Mai soli.

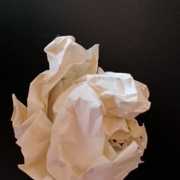


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!