Stranieri. Cosa possono fare i poeti? (VersanteRipido, 1.5.18)
STRANIERI – cosa possono fare i poeti?
Editoriale in “Versante Ripido” 1 maggio 2018
I poeti, a mio parere, possono e devono smetterla di fare l’arte per l’arte, non è più tempo: il mondo chiama, la realtà s’impone. La geografia del mondo sta cambiando sotto i nostri occhi e la poesia deve cambiare di conseguenza. Sul concetto di “straniero”, “estraneo”, “diverso”, la prima e la terza delle poesie che vi propongo risponderanno meglio di qualunque mia prosa.
Approfitto di questa prima affermazione per affermare un secondo pensiero, che può sembrare una provocazione, ma non lo è: la poesia si capisce meglio della prosa, al contrario di quello che si pensa, perché ci raggiunge più immediatamente e più in profondità, adopera nello stesso tempo molti canali di comunicazione: la musica, il rapimento emotivo e, insieme, il lusso di una doppia intelligenza, etimologica e dotta insieme.
I poeti producono questo effetto multiplo avvalendosi del silenzio e dei salti logici, mentre la prosa, per come comunemente la intendiamo, non suggestiona ma racconta, dunque lavora sulla conseguenzialità del pensiero e del pensiero sintattico. Il pensiero poetico, anche quello espresso in forma argomentativa filosofica, è comunque pensiero cantato e circondato da un luogo muto, l’aria messa nel bianco intorno alle parole.
Se è vero che i poeti sono creature sensibili, al mondo contemporaneo non basta che dedichino la propria sensibilità esclusivamente alla lingua – non basta che siano i custodi dell’identità linguistica del paese, anche perché l’identità linguistica del paese è prossima a cambiare: secondo i demografi, alla fine del Secolo Ventunesimo tutto il mondo sarà abitato da cittadini creoli, proprio come avvenne nell’Alto Medioevo, l’epoca “devastata dai barbari”, dalla quale, però, è nata l’Europa.
Ora siamo in un nuovo mutamento epocale e sarebbe utilissimo al mondo se tutti ci mostrassimo disponibili a formare una coscienza mondialista, se ci preparassimo con serenità al meticciato, della lingua e del sangue (ammesso che tra lingua e sangue ci sia differenza).
Mescolarsi non significa perdere la propria identità, significa aumentarla, aggiungere qualcosa a quello che già si è, come avviene ogni volta che si impara.
Riporto, a questo proposito, le parole della scrittrice somalo-italiana Ùbax Cristina Àli Fàrah che, nella sua breve introduzione ai propri testi, descrive con parole illuminanti la confluenza di esperienza e suono nella lingua adottata, l’italiano:
“Scrivere e utilizzare l’italiano nel tentativo di conciliare un linguaggio solamente letto con le sonorità e le strutture del somalo, è stato un reiventarmi un mondo al quale sentivo finalmente di appartenere, un riappropriarmi di tutto ciò che nella realtà non poteva coesistere…”
Far confluire in sé i molti aspetti della propria vita, dunque, attraverso la scelta della lingua nella quale scrivere. Un’operazione che ha a che fare con la cosiddetta realtà e con la nostra propria biologia.
E infine: in quanto partecipante al progetto “La Frontiera”, ideato da Elena Stancanelli e Alessandro Leogrande, e come componente dell’Associazione “Piccoli Maestri” (lettori volontari di libri altrui nelle scuole), ho posto alla linguista Valeria Della Valle una domanda a proposito della prossima possibile contaminazione del nostro italiano, che provocatoriamente definivo “asfittico e letterario”, con le lingue arabe e africane – e la domanda ha indotto Della Valle a una riflessione utilissima a tutti: a parte “kebab”, tutte le parole arabe che sono entrate nel suo e nel nostro uso (“jihad”, “burqa”), sono parole negative.
Questo processo va radicalmente invertito.
da Il bene morale (Crocetti, 2017)
io cerco che la vita sia all’altezza del canto
poi, ci siamo sedute
vicine, senza spazio tra i corpi, senza rispetto
di quello che chiamate “spazio vitale”: voi, tutti, qui, occupati
a difendere l’aria, la libertà, a dimenticare
l’umano che cerca la vicinanza
come un bambino
poi, ci siamo sedute
sul marciapiede
e abbiamo fatto un pezzo di Somalia
– montuoso, ondulato, colorato,
sconnesso
e fermo – un pezzo di fusione
di nove corpi
neri
in terra straniera
ci hanno dato qualcosa, dei fazzolettini. una prima accoglienza. sandali, infradito e marciapiede. solo una di noi
sta di profilo, parla, fa sorridere
un’altra
la riga bianca del sorriso. poi, il bagliore di un occhio, due, la postura scomposta di una: forse
la più stanca, forse
la più sfacciata. o è la stanchezza, a renderla sfacciata. però, quasi sorride.
siamo righe di sabbia
incomprensibile. eppure
basta poco, a conoscere, basta
identificarsi
anche la donna
che scrive di noi, lo vedete, sta dando per scontato
che le straniere
siamo noi.
eppure…
eppure…
Roma, 19 settembre 2016
queste mani tenevano la loro creatura sopra l’indifferenziato del mare
Secondo il più recente rilevamento sugli arrivi via mare in Europa, reso noto dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), il numero di rifugiati e migranti che, dall’inizio del 2016, ha attraversato il Mar Mediterraneo per sbarcare in Europa ha ormai raggiunto quota 288.005. Tra questi, 121.155 sono arrivati in Italia e circa 164.146 in Grecia. Il numero di morti e dispersi in mare è stimato in 3.171. I dati sono aggiornati al 4 settembre 2016.
Un poeta è profondamente coinvolto con le cose del mondo. Il suo compito è mantenere la memoria della comunità umana. Il suo compito è ricordare la grandezza possibile della nostra persona. “Quando entrano in gioco le pulsioni di auto-conservazione dell’io, il principio del piacere viene sostituito dal principio della realtà. Quest’ultimo […] mette in atto la temporanea sopportazione del dispiacere, come tappa nel lungo e contorto cammino verso il piacere.” (Freud) Il temporaneo dispiacere è vedere le cose come stanno, cioè che siamo creature sofferenti, crudeli e sole in misura variabile. Il massimo piacere, l’utopia del piacere, è la circolazione fluida dell’amore umano. Per ciò abbiamo inventato il paradiso.
Dato l’assunto che il poeta conservi in sé la memoria e lo slancio sufficienti per risuscitare anche negli animi più disillusi e oppressi il desiderio e il coraggio di sperare in una “comunità umana”, possiamo dire che la poesia risusciti l’utopia del piacere. E che, per ciò, sia la spina nel fianco, che ci ricorda come vorremmo che le cose fossero. Oltre il più quotidiano disincanto. Per ciò viene pensata tanto distante dalla faccenda umana: guardata con sospetto e rifiutata, perché riguarda il nostro sogno più alto e troppo pericolosamente amato, è il “seme fecondo e disperato” di De Angelis, incarna la nostra paura di illuderci come bambini. Per fortuna i poeti sono vivi, abitualmente adulti, e fanno le cose.
Questa excusatio non petita mi pare una premessa doverosa, che, mentre cerca di oltrepassarlo, documenta l’imbarazzo di chi scrive, di fronte ai risultati della crudeltà umana. Provo molto imbarazzo a fare poesia su tutte queste creature prese dal mare per colpa della parte peggiore dell’umanità, che è quella che osservo e ripudio. In primo luogo, dentro me stessa, quando la rintraccio: nella mia paura, nella mia volontà di prevalere, ma soprattutto nella mia indifferenza.
E allora, mi domando: dalle sponde di questo morto occidente, sotto la più leggibile paura, sale forse un rancore nostro, nei confronti di chi coltiva un sogno?
davanti al mare è questo orfanotrofio
senza utopia, la forza armata
di questa inespugnabile infelicità
che non ha più nessuno da aspettare
e invidia la vita
siamo noi gli ignavi, abbiamo vite
armate
per non riconoscere la nostra paura nella paura
degli altri, il nostro
respiro nel respiro
degli altri – il singolo respiro
nella massa di quel respiro umano che si gonfia e non basta
a fermare l’ondata
immagina che sia tua
la vita che chiede asilo
immaginiamo che sia nostra
la disperata utopia
di questo gigantesco
voler rinascere
immaginiamo siano i nostri corpi
questi corpi lasciati
a cadere nell’indifferenziato come orfani
l’assoluto abbandono della nascita di un orfano è senz’altro paragonabile all’abbandono nel quale è gettata ognuna di queste vite
che chiede di rinascere
quando sono i figli a morire, non esiste nemmeno la parola per dirlo. anche la liturgia, in quei rari, emblematici casi, si avvale di perifrasi : O Maria cum filio tuo mortuo…
biancore sovraumano di legno morto
– figlio mio
fatto di carne
umana
combustibile,
marcescibile
figlio mio
nel bruciare
del sale, riconosco il tuo odore di selva
e di laboratorio solare, quel profumo sensibile di pelle fresca e cotone
lavato – poi
per un attimo, riconosco lo sguardo dei tuoi occhi
che ho portato con me, in questa vita
che non arriva più
Roma, 24 giugno 2016 (in “Poesia” n. 319, Ottobre 2016)
Canto bosniaco o Della maldicenza
Dragan e io eravamo fratelli
e ci hanno messi uno contro l’altro.
Spesso nei fine settimana io, mia moglie e la piccola Ana mangiavamo a casa sua, perché sua moglie Amina sapeva fare il ćevapčići di montone meglio della mia.
La mia Sofija faceva finta di sorridere, ma ogni sabato pomeriggio si tirava il grembiule sui fianchi come una cotta da guerra e ricopriva le baklava con tanto miele e pistacchi da sfamare un esercito.
Secondo me il ćevapčići di Amina era così saporito perché metteva nella salsa i peperoni rossi che Dragan coltivava nella serra. Ma noi maschi sappiamo approfittare dei bisticci delle donne. Le femmine trovano sempre scuse per offendersi, ma sotto sotto non possono fare a meno una dell’altra. E a noi ci piacciono, così infiammate.
Le lasciavamo beccarsi in silenzio e ogni sabato sera ci godevamo una cena da papi. Da sultani, mi dava di gomito Dragan…
Poi, iniziarono a circolare voci: Guardatevi le spalle, i musulmani sono traditori e bugiardi, vogliono rubarvi in casa – e, sempre peggio – vogliono ammazzarvi i figli! Non hanno scrupoli, sono i nostri nemici.
A loro dicevano lo stesso di noi.
Ci vuole poco, a dividere uomo da uomo. Basta il sospetto.
Cominciamo a studiarci da lontano, a pesare ogni gesto.
Ognuno vedeva quello che temeva di vedere.
Iniziamo a trovare scuse per il sabato sera, a sorriderci meno, quando ci incontriamo sul sentiero. E per forza, abitiamo vicini. Solleviamo la mano e tiriamo dritti quasi correndo, neanche ci stesse bruciando la casa.
È il cuore che ci brucia, a vederci così. E allora, facciamo il giro largo e non c’incontriamo più.
La mia piccola Ana è la mia gioia. Alla sera, chiudo bene le imposte. Sofija controlla tutte le serrature. Che ci possiamo fare, questa è la vita. Un sospiro e ci addormentiamo.
Ci continuano a dire state attenti, ci imbevono d’odio e di paura come Sofija le sue baklava al miele. Tutti i giorni, tutti i giorni. Siamo appiccicosi di paura.
Un altro mese e comincio a tenere la pistola sotto il cuscino, non si sa mai.
Dragan, se lo vedo al mercato del paese, ormai neanche lo saluto più. Meglio così.
Una mattina presto, era d’estate e il sole già bruciava, stavo tagliando il grano e lo vedo passare tra i girasoli e andare dritto verso casa mia.
Ha messo la camicia, con il caldo che fa.
Lo vedo che si affaccia alla finestra della cucina e s’infila una mano nella tasca di dietro dei calzoni.
Lo ha raccolto Sofija, che l’ha visto sparire dal quadrato di luce della finestra ed è uscita a guardare. Dice che aveva un accendino in mano e la faccia di uno che non capisce.
Aveva iniziato a fumare. Io che colpa ne ho, non lo sapevo.

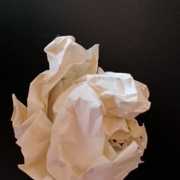


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!