Cassavetes John, Una moglie (Cineprints, 2016)
SU JOHN CASSAVETES
con testi di M. G. Calandrone, J. Costantino
cover poster di S. Rondelli
(tiratura limitata, esemplari numerati)
Una moglie, ovvero: amare uno sconosciuto oggetto d’amore
A Cassavetes, per sua stessa dichiarazione, non importava il cinema, importavano le persone. Possiamo intendere che adoperasse il cinema come un mezzo per entrare in contatto profondo con il nucleo vivo degli altri. L’irriducibile alterità dell’altro è la protagonista dei suoi film. E tanto più lo è in un film come Una moglie, dove la moglie è la vera sposa del regista: Gena Rowlands, alla quale viene chiesto di esprimere la propria “follia”, il seme alieno, intrattabile e bastardo che ciascuno di noi porta in sé.
Una moglie (consideriamo raddrizzato il corsivo che ne fa solo un titolo) è un oggetto sporco e ingovernato, come sporca e ingovernabile è la vita. Dunque, come la vita, pone questioni radicali.
La prima è: il marito (un perfetto, scimmiesco, gutturale, grossolano e tenero Peter Falck) ama o non ama una moglie alla quale non ha accesso?
Ovvero, ancora più pericolosamente: che significa amare?
Come sempre in John Cassavetes, ma particolarmente in questo film, l’altro è propriamente e integralmente altro: i mondi di Mabel e Nick appaiono così incomunicanti che siamo indotti a chiederci come e dove abbiano potuto una volta incontrarsi: se per chimica organica, per idealizzazione o per sfida.
Siamo ormai a cose fatte: molti anni sono passati, i figli sono nati e la sfida non è stata vinta: i due protagonisti sono soli. Ma sono legati, indissolubilmente. Nick sta vicino alla moglie con calore animale. Con rabbia, tenerezza e disperazione.
Il problema che Cassavetes mette in scena è ancora una volta la fatica di conoscere l’oggetto del proprio amore. In questa circostanza, l’impossibilità di accettare l’irriducibilità del proprio oggetto d’amore.
Riflettere su Una moglie significa dunque soppesare gli equilibri tra libertà e ferocia nelle relazioni che convenzionalmente ci accompagnano, significa indagare le quote di salvezza ipotetica (amare qualcuno ci dà il diritto di intervenire nella sua vita come fa Nick, facendo internare Mabel al fine di “guarirla”: di normalizzarla?) e solitudine assegnate all’amore quotidiano, pratico, che non è fuoco che brucia, ma corpo vivo che accoglie e non comprende, non avvolge nel suo abbraccio l’intera persona dell’altro.
“Ogni cosa che ho visto di te, te la restituisco amata”: questo credo sia il succo dell’amore umano, dell’amore possibile su questa terra. L’amore di Nick per Mabel non è questo: Nick si trova a convivere con un oggetto incandescente, con una moglie che agisce in pubblico comportamenti destabilizzanti, anticonvenzionali e, allo stesso tempo, con una donna non abbastanza forte da non fare struggentemente di tutto per piacere agli altri, per adeguarsi alla richiesta affettiva e sociale, per consolare la disperazione dell’altro, che la guarda senza includerla nel suo abbraccio incondizionato. Mabel sembra così, a sua volta, una bambina disperata, al bivio amletico tra esistere e non esistere, vedendosi negata l’approvazione.
Il ménage matrimoniale dei due non è disponibile al cambiamento. Nick non è disponibile ad accogliere l’onda anomala della personalità di Mabel, che deve venire contenuta e incasellata nei ruoli di madre e moglie amorevole e tranquilla. Anzi: pacificata – se non dalla vita, dagli psicofarmaci e dagli elettroshock.
La battaglia di Mabel per l’autoaffermazione non è comunque data, perché lei stessa non ha la forza, se non a tratti e sempre dubitando, di adoperare la propria energia come pulsione e propulsione creativa: Mabel non riesce a canalizzare il proprio fiotto di disordine in una forma di espressione socialmente accettabile: lo libera, piuttosto, davanti all’imbarazzo e allo scherno degli altri, e ottiene un risultato di dolore, collettivo e comune. Il marito è imbarazzato e perturbato da questa moglie, che si comporta come rilasciando in pubblico le sue scorie ulcerate, il proprio uranio, la radioattività di una solitudine umana che deve rimanere, per convenzione: segreta.
Nascosta a chiunque.
Però, non l’abbandona. Potremmo dedurne che provi amore. Se amore fosse tenere accanto qualcuno al prezzo di smontarlo per ricostruirlo diverso. Fin dentro le ultime scene, Nick desidera restringere la personalità di Mabel nelle coordinate cartesiane di un mondo dentro il quale egli stesso è prigioniero, così intruso da una madre esasperante e dai ritmi del superlavoro.
Nick ha bisogno di Mabel, che però non sa rispondere ai suoi desideri, pur desiderando assecondarli. Nick ha bisogno di una Mabel che Mabel non è. Mabel ha bisogno di Nick, che però non accoglie l’interezza della sua persona ed è fatto di cose che fanno male a Mabel.
Dunque che cosa lega le due creature?
Forse una inconsapevole e negata speranza. Forse una combattuta, non ancora rassegnata attrazione: Mabel potrebbe essere un motore ideale di gioia e libertà creativa, se lei stessa non si ponesse il problema di rispondere “bene” e “giustamente” a una domanda aliena alla sua natura: sociale e microsociale: familiare. Purtroppo la sua microsocietà non l’aiuta, non l’accompagna, non combatte al suo fianco. Nessuno sta “dalla sua parte”. Neanche i figli. Questa la scena più malinconica e dolente nella piccola orchestra del film.
Come reagiscono i bambini a una madre diversa dalle altre, soprattutto a una madre che è stata trattenuta lontana dai loro piccoli corpi? Rispondono comunque con lo slancio di un incondizionato amore? No, non così. I figli hanno perduto la consuetudine con il corpo della madre, la totale confidenza animale nel corpo della madre come riparo da tutte le tempeste. Perché lo stesso corpo di lei è portatore di una tempesta alla quale non è stato dato diritto, che è stata anzi arginata con violenza, esiliata dal nucleo dei suoi amori primari. I figli conseguono al messaggio parentale ricevuto: sono estranei alla dolorosissima, infantile gioia della madre, che pure tentano di accogliere, scavalcando a parole quasi formali la ferita comune.
Mabel è sola. Cede. Desidera togliere dalla superficiale superficie del mondo il proprio disturbo. “Disturbo” psichiatrico, è così che si dice. La sua viva esplosione di dolore però le vale, in extremis, la solidarietà desiderata: il dolore di Mabel ha preso la parola attraverso il corpo – e ha trovato un istintivo, finalmente acritico e primordiale ascolto, in chi ancora conserva il terrore della sua perdita.
Così, la tormenta e il tormento paiono acquietarsi nell’abitudine di riposare insieme chiudendo fuori il mondo, dopo aver fatto ordine nello spazio domestico. Basta questa compiacenza, a portare la pace? Basta questo che pare un accucciarsi una accanto all’altra di anime ferite?
Con le sue inquadrature sbilenche e il finale socchiuso, questo film è e rimane fino ai titoli di coda: soffocante. Perché “è la libertà di esprimere la propria profondità ad essere rivoluzionaria”, come dichiara Cassavetes a Yves Bourde per “Le Monde”. La libertà di essere, sì, certo, basterebbe. Ma in questo film amaro e perturbante la libertà è accaduta in un lampo, che lascia sulle cose l’ustione di un’inquietudine profonda, un sentimento grave di pericolo e di precarietà.
Eccoci dunque all’ultima domanda: come decidere se una persona sia viva o morta, se la vediamo camminare ancora?
Ci servirà capire il suo sorriso. Anche dietro la tenda che si è chiusa.

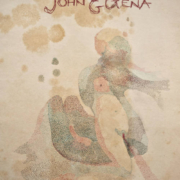


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!